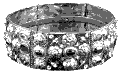Torna, puntuale come ogni anno dal 1945, il 25 Aprile. Nominalmente questa festa ha lo scopo di commemorare l’avvenuta liberazione dell’Italia dalla tragica occupazione del Terzo
Reich nazionalsocialista e dall’ultimo regime mussoliniano e, inevitabilmente, le tante vittime: italiani e stranieri, militari e civili – caduti, giustiziati, torturati, deportati, in qualche modo colpiti nella salute, negli affetti o nei beni –, che questo sforzo collettivo è costato.
Se cerchiamo di capire, in ordine di importanza, quali sono stati gli artefici di questa liberazione, al primo posto, ovviamente, non si possono non situare gli eserciti alleati: americano, inglese e della Francia Libera — con tutte le loro le propaggini coloniali: marocchini, maori, sikh, canadese, polacco, sudafricano, neozelandese, australiano – che hanno sconfitto militarmente le forze germaniche. Quindi il contingente italiano che dopo l’8 settembre 1943 iniziò ad affiancare gli Alleati nella riconquista della Penisola, combattendo con valore a Mignano Montelungo (Caserta) e Filottrano (Ancona).
Solo dopo, quindi – non me ne voglia il Presidente Giorgio Napolitano, il quale nel suo discorso del 23 aprile a Forno di Coazze, in provincia di Torino, ha detto che la lotta partigiana fu «decisiva» e «determinante» –, vengono le formazioni irregolari promosse nel Centro-Nord innanzitutto da resti dell’esercito nazionale e poi anche dai partiti politici rinati dopo il ventennio autoritario: partigiani monarchici, azionisti, cattolici, socialcomunisti.
Infine, vengono i privati cittadini, di tutti i ceti, che parteciparono alla lotta clandestina o furono coinvolti nel conflitto uti singuli. Fra costoro le vittime furono altissime: vittime di rappresaglie ed eccidi, persone arrestate perché ritenute sostenitori dei partigiani, semplici ostaggi, militari internati in Germania, civili e soldati arruolati nelle organizzazioni di lavoro forzato come la Todt.
La celebrazione dovrebbe quindi seguire questa scala di precedenze e aprirsi con un tributo di onore ai tanti caduti alleati, da Salerno a Cassino, da Anzio fino alla Linea Gotica.
In realtà, fin da principio le commemorazioni annuali della liberazione hanno seguito un altro e ben diverso copione: la componente del fronte resistenziale che, sovvertendo le precedenze, ha fatto la voce più grossa, indossando i panni del vincitore unico e definitivo, sono stati i reduci e gli epigoni delle formazioni armate socialcomuniste, inquadrati nell’Anpi, che un po’ alla volta è riuscita a eclissare tutto il resto della galassia associativa dei combattenti e dei resistenti trasformando il 25 aprile in una festa politica. Ovvero in un momento vessillare della solidarietà «ciellenistica» del 1943-1947, il cui ripristino è stato l’obiettivo costante delle forze di estrema sinistra dal 1948 in avanti, cioè un’occasione per ribadire che questa formula politica «escludente» era la sola legittimata a governare il Paese in quanto artefice unica della liberazione e della costruzione della Repubblica.
Nonostante il riequilibrio imposto dalla riedificazione dello Stato di diritto, dalla nuova Costituzione e dalla rinascita di una nozione meno ideologica dell'identità nazionale con le elezioni del 1948, da una certa data in avanti il 25 aprile ha rappresentato costantemente l'occasione per lanciare al Paese il messaggio che vi era una parte degl’italiani legittimata a dirigere e un’altra – quanto grande fosse non importava – a subirne la volontà. Gli esclusi ovviamente erano i reduci dell’esperienza fascista sconfitta, i monarchici, i conservatori, i moderati, i cattolici «integralisti», gli anticomunisti, e via via sempre più selettivamente anche non pochi dei compagni di strada, a partire dai partigiani non comunisti alla Edgardo Sogno o alla Randolfo Pacciardi. L’antiamericanismo delle sinistre – in forte crescita negli anni della guerra del Vietnam del Sud (1962-1975) e il suo forte residuare successivo – faceva poi automaticamente mettere in secondo piano – se non proprio tacerlo – anche ai massimi livelli di autorità il ruolo svolto nella liberazione dalla coalizione militare anti-hitleriana messa in atto sotto la regia americana.
Oltre a ciò, si dimenticava, ancora, che il fascismo era imploso da solo, che la Repubblica di Mussolini aveva oggettivamente attenuato il peso della vendetta germanica contro l’alleato traditore, che ben ottocentomila giovani italiani non erano, come tanti altri, andati a ingrossare sui monti le formazioni partigiane per sfuggire ai «bandi Graziani», ma avevano scelto di difendere a modo loro l’onore italiano e avevano combattuto con valore contro gli Alleati, che chi si arrogava il ruolo di nucleo «motore» della Resistenza era prevalso solo grazie ad altri, che i martiri della lotta non erano stati solo i comunisti, che enormi erano state le sofferenze di tutti gl’italiani e che queste talora erano state acuite proprio dal modo – cioè con pochi scrupoli, secondo i canoni della guerra sovversiva rivoluzionaria insegnata a Mosca – con cui le formazioni terroriste comuniste nelle città del Centro e del Nord avevano agito contro tedeschi e quadri fascisti.
Se questo squilibrio di toni, se questa distorsione di visuale può essere comprensibile nell’immediato dopoguerra, quando l’abbrivio e le passioni della lotta sono ancora intensi, non si può certo giustificare nel prosieguo.
Il 25 aprile non è mai stata una festa nazionale veramente e collettivamente sentita, nonostante il peso straordinario messo sulla bilancia in ogni occasione dalle istituzioni nazionali e locali. E questo non certo per l’offuscamento dell’icona resistenziale verificatosi oggettivamente negli anni dei governi democristiani – la mitologia resistenziale sarà rilanciata con straordinaria veemenza non appena saliti al potere i socialisti nel 1963 e conoscerà l’acme negli anni della devastante ventata neocomunista post-sessantottina –, ma perché l’appello era sentito in ultima analisi solo da una percentuale nemmeno elevatissima del corpo nazionale.
In quella data, infatti, non tutti potevano gioire: per esempio i vinti del 1945, i congiunti – o semplicemente gli spettatori: mia madre mi raccontava delle montagne di cadaveri di militi fascisti e di civili che vide accatastati al Cimitero Maggiore di Milano nei giorni seguenti il 25 aprile 1945… – delle vittime della feroce e prolungata vendetta antifascista del 1945-1948, i cui estremi e le cui dimensioni solo ora stanno affiorando, insieme ai resti dei sepolti nelle fosse comuni e i familiari degl’«infoibati» dai comunisti jugoslavi.
Senza dimenticare gli orfani dei morti nei bombardamenti dell’air force alleata, reclamati – pare – dal direttivo del Cln Alta Italia, le contadine «marocchinate» nei dintorni di Cassino, e i reduci dai duri campi di prigionia alleata. Infine, gli anticomunisti, cattolici e non, politicizzati e non, che vedevano esaurirsi un po’ alla volta la virata contraria al «vento» della Resistenza che il 1948 aveva impresso al Paese, così come, in generale, tutti coloro che capivano che l’enfasi sulla Resistenza e sulla Resistenza «rossa» avevano un carattere fondamentalmente fraudolento e ricattatorio.
Così come la maggioranza degl’italiani, “anti-politica” da sempre, ma ancor di più dopo l’8 Settembre, in quella data ha sempre pensato piuttosto ad “andare al mare”, che non a scendere in piazza.
Non voglio, dicendo quel che dico, porre sullo stesso piano nulla: anche in una guerra civile esistono ragioni e torti oggettivi, che non sono cancellati dalle scelte personali ed è più che legittimo per il Paese celebrare un evento importante come la Liberazione. Voglio solo denunciare un uso abusivo e ripetuto di una commemorazione piegata a finalità diverse da quelle «naturali» e accompagnata da pesanti omissioni e palesi ingiustizie.
Se la giornata di aprile fosse stata promossa e vissuta con un diverso spirito, avrebbe potuto davvero diventare festa di tutti, la vera giornata della riconciliazione nazionale dopo le lacerazioni e i lutti di un quinquennio devastante.
Ma non è andata così e gli appelli a «[…] ricomporre in spirito di verità la storia della nazione, la storia della Repubblica, per giungere finalmente ad un comune sentire storico», come auspica oggi il nostro Presidente, si rivelano forzatamente sterili.
Molta acqua è passata sotto i ponti, ma nulla pare incrinare la ferrea determinazione di alcune residuali forze politiche di trasformare – fra ancor flebili distinguo delle più alte istituzioni – di nuovo il 25 aprile in un «tribunale rivoluzionario allargato», destinato a giudicare in nome di un popolo fittizio il popolo reale stesso e le sue scelte pubbliche. Pare non siano serviti la rimozione del muro di Berlino e la fine dell’Urss fra il 1989 e il 1991, né la fine dei partiti antifascisti del 1945 e del 1948, né i chiari segnali che il corpo sociale invia, almeno dal 1994, di una sua ogni giorno più forte allergia all’ideologia progressista, alle prese di posizione astratte, all’ulteriore appesantimento della sfera pubblica, ai sacrifici patiti dell’accoppiamento di una sempre più rigorosa – e costosa – applicazione del «politicamente corretto» imposto dalla sfera politica con una carenza sempre più evidente di strutture efficienti di servizio e di sicurezza personale.
Anzi, c’è addirittura chi parla di ripristinare la festa del 20 settembre 1870, quando la Roma di Pio IX fu occupata dal Regno d’Italia, una festa messa in sordina dal Concordato del 1929 e che solo i circoli anticlericali e le logge massoniche continuano a celebrare, così avremmo non una ma due ricorrenze altamente divisive, una che celebra la vittoria nella guerra civile, l’altra che solennizza la sconfitta politica e, anzi, preconizza l’imminente tramonto spirituale – questa volta non di un semplice partito o di un regime, ma – della Chiesa cattolica stessa.
La discrasia fra la sfera dei presunti valori che il 25 aprile — così com’è celebrato — veicola e la realtà di un mondo che non è più quello del 1945 pare oggi al culmine e bisogna quindi aver il coraggio di cambiare. I mezzi sono tanti, alcuni semplici – qualche segnale, di buona carica simbolica, viene dalla Presidenza del Consiglio –, altri invece di lungo periodo.
Purtroppo, credo, che una rettificazione delle finalità e degli accenti della Festa della Liberazione potrà darsi solo quando i vertici della Repubblica accetteranno di rimettere in discussione quell’obsoleta pregiudiziale «antifascista» che, pur meno riscontrabile nelle carte fondamentali, grava di fatto come una pesante spada di Damocle su ogni azione che intenda a migliorare i lineamenti della convivenza civile dei popoli della Penisola. Ma soprattutto quando si abbandonerà la rigida, antistorica e ipocrita difesa dell’attuale Carta e si deciderà di riscrivere le regole del gioco tenendo conto non solo del nuovo, ma anche del passato – anche di quello più profondo – e di quanto il passato ci dice in relazione alle nostre radici comuni. Personalmente vedo oggi questo cammino assai difficile, in quanto l’attaccamento a paradigmi divisivi da parte di certe forze – vogliamo fare, per esempio, il nome della Cgil? – non è unicamente questione di debolezza di pensiero e di scarsa creatività, ma proprio unica ragione di sopravvivenza politica, rimossa la quale vi è solo il vuoto.