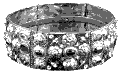All’inizio di agosto l’on. Gianfranco Fini ha scritto un lungo articolo per
formiche (anno VI, n. 40, agosto-settembre 2009, pp. 4-7), periodico della omonima fondazione milanese, sul tema
Un moderno patriottismo. Costituzionale, nazionale, repubblicano ed europeo. L’articolo merita qualche commento per la delicatezza della materia che tratta, per il peso dell’autore, ma anche per non poche argomentazioni difficilmente condivisibili e per l’inconsueta approssimazione culturale che rivela.
Tralascio ogni considerazione – non perché sia cosa insignificante, ma perché in questa sede mi preme sottolineare altro – sulla repentina e chiacchierata inversione di marcia in materia politico-culturale del Presidente della Camera.
Venendo ai contenuti, i punti che andrebbero commentati sono molti e disseminati un po’ ovunque nel testo. Per non farla troppo lunga, cercherò di cogliere solo quelli che mi paiono più importanti.
Va premesso che pare del tutto apprezzabile la denuncia allarmata, che nell’articolo la terza carica istituzionale dello Stato italiano fa, dei segnali di scollamento della compagine nazionale, nonché il vibrante appello a rinsaldare il tessuto della nazione. La tempistica scelta tradisce però come questa preoccupazione sia imputata soprattutto al neo-separatismo leghista. Il che è forse vero, ma alquanto unilaterale. L’allentarsi del sentimento d’italianità non nasce infatti con la Lega, la quale, anzi, ha reintrodotto nel popolo un po’ di passione identitaria, benché localistica. Un uomo che è stato segretario del Fronte della Gioventù e di Alleanza Nazionale non può non rammentare che esso ha radici «trasversali»: risale da un lato alla reazione generale contro l’ubriacatura nazionalista del fascismo, dall’altro alla nausea post-8 settembre 1943, ma soprattutto all’egemonia della cultura internazionalista e al pacifismo cristiano del dopoguerra, senza dimenticare, su questo versante, il diffuso nichilismo attuale. È dunque un fenomeno vecchio: mostrarsi allarmati ora puzza di polemica strumentale.
Inizio dal nesso fra Costituzione, nazione e cittadinanza che viene immediatamente premesso. Parlarne mi pare un’ovvietà: è un nesso che può esistere e oggi esiste in concreto nella maggior parte dei Paesi. Ma non è un nesso necessario. La nazione è il corpo storico di un popolo: è un dato, un portato della storia. Lo Stato, dunque la cittadinanza, può esserci ed è bene che vi sia, ma può anche non esserci. Infine la Costituzione: esistono nazioni senza Stato, e nazioni con uno Stato e senza una costituzione, perché la legge fondamentale è la consuetudine. Per esempio l’Inghilterra, che è una delle «moderne democrazie»: chi oserebbe negarlo? Ciò premesso, le moderne democrazie sono il modello assoluto di ogni ordinamento? Forse che altre forme di Stato o di governo sono prive di dignità e chi le sostiene un demente o un deviante? Questo assunto pregiudiziale che apre l’argomentazione di Fini rivela già l’adesione a una dottrina e a una mentalità ‒ progressiste ‒ che si danno per scontate, mentre non lo sono.
«È necessario più che mai mantenere vivi e attuali i valori repubblicani, che vanno intesi sia come lealismo e senso di appartenenza alla Repubblica sia come passione civile per le sorti della Res Publica e quindi per tutto ciò che rimanda alla nazione intesa come comunità politica dei cittadini», afferma Fini. Ma che cosa vuol dire quest’assunto retorico? Passi per il lealismo, visto che oggi, di fatto, nazione italiana e Repubblica Italiana non sono scindibili, soprattutto agli occhi degli stranieri. Ma chi ha detto che la forma repubblicana e il senso di appartenenza a quest’entità astratta che è la Repubblica coincida con la passione per la cosa pubblica? La passione civile si nutre di ben altro: di virtù umane e di senso civico, che si possono dare sotto qualunque regime. E non è una tensione permanente, ma legata a frangenti non ordinari, in cui la comunità affronta pericoli, mutamenti, sfide, opportunità. Pensare a una permanente mobilitazione dei padri di famiglia intorno a mete generali o astratte è pura utopia. Diverso è il discorso per il personale politico, ovviamente. La nazione poi non è la comunità politica dei cittadini: la comunità politica è l’organizzazione-guida ‒ ovvero lo Stato ‒ che una nazione si dà per propria difesa e le regole per farla funzionare. Esiste poi solo il senso di appartenenza «verticale»? non è più importante quello «orizzontale» fra individui e comunità?
Fini scrive ancora: «[…] la nostra democrazia, come tutte le democrazie del mondo, necessita della partecipazione attiva dei cittadini». Giusto: se democrazia è partecipazione del soggetto della sovranità al suo esercizio, quanto più si partecipa tanto più il sistema funziona e si toglie spazio alle lobby. Ma sarebbe illusorio pensare a una partecipazione politica alta ‒ anche se le occasioni non sono molte nei regimi elettorali ‒ senza una partecipazione prima alla società, ed è questo che oggi manca. Oggi chi va a votare con assiduità e con scrupolo magari non si accorge che il vicino di pianerottolo è morto da tre mesi.
Vi è poi un passaggio veramente discutibile: bisogna infatti «[…] rinverdire le linee ideali e morali espresse dalle grandi culture politiche del Novecento, che hanno trovato la loro sintesi nella Costituzione», dice Fini. Significa allora rianimare il marxismo e il leninismo, riabilitare il socialismo, rilanciare il democratismo radicale, rifare la democrazia cristiana – intesa come pensiero e non come partito –, far risorgere il virulento e iettatorio azionismo? Tralasciando ovviamente le ideologie «di destra», quelle che ho nominato sono tutte ideologie del 1900 e tutte sono confluite nella Costituzione… Se così è, allora perché dobbiamo tenerci una Costituzione con questo pedigree? Perché dobbiamo avere una «mentalità da democrazia matura»? In questo sta la maturità? O non, piuttosto, far tesoro dei drammi che queste ideologie hanno generato su scala mondiale e imboccare la strada radicalmente opposta?
Ma non è tutto. Fini prosegue: «l’educazione al patriottismo costituzionale inteso come moderno amor di patria è uno degli strumenti privilegiati per promuovere un moderno sentimento di unità del Paese. Tale forma di patriottismo implica inevitabilmente il riconoscersi da parte dei cittadini nei valori sanciti dalla Carta». A parte l’abuso, anch’esso rivelatore, del termine «moderno» ‒ che ha una strana assonanza con l’uso oltre ogni decenza dell’aggettivo «nuovo» che fanno i post-comunisti alla D’Alema ‒, come si può affermare il nesso Costituzione-patria-senso unitario quando la nostra Carta, come ha appena detto, è il distillato del pensiero di un secolo che ha visto più morti violente e martiri di tutti gli altri messi assieme e, in quanto ideologico, è divisivo di suo? Non è meglio pensare di raggiungere l’unità riformando gradualmente negl’italiani ‒ con metodi possibilmente diversi da quelli farseschi adottati dal fascismo ‒ quelle virtù naturali principali – temperanza, fortezza, prudenza e giustizia – che sono di loro natura cattoliche e che, sole, quando si riversano nel pubblico riescono ad aumentare il senso civico?
Infine, dopo le premesse analitiche, Fini lancia la sua ricetta, il suo slogan: «patriottismo costituzionale, nazionale e repubblicano», alternativa riveduta e corretta del semplice «patriottismo costituzionale» «freddo», invocato da più parti «da sinistra».
La pezza d’appoggio della correzione? «Il patriottismo costituzionale, nazionale e repubblicano è inseparabile dall’ideale democratico e sociale che rimanda alla storia stessa del Risorgimento». Testimoni? Quattro – e solo questi quattro! –: Mazzini, Calamandrei, Habermas e Rousseau.
E qui casca – o, meglio, è già cascato, ma, diciamo, qui «fa il botto» – l’asino. Infatti, la ricetta sta in piedi solo se l’ingrediente-base è «l’ideale democratico e sociale che rimanda alla storia stessa del Risorgimento». Ovvero, se si indossa la versione socialdemocratica, nemmeno più quella liberale, dell’ideologia risorgimentale. Il Risorgimento in versione democratica è la condizione per attivare il circolo virtuoso patria-costituzione-unità sociale.
La scelta della «banda dei quattro» è davvero azzeccata. Certamente, «in principio erat Mazzini»: chi meglio del Genovese emblematizza questa vena «democratica e sociale»? Ma, chiedo, che cos’ha da dire a un italiano di oggi uno spiritualista non cristiano, un settario impenitente, un insurrezionalista-pantofolaio e nemico giurato dell’animus cattolico e delle diversità naturali e storiche del corpo sociale italiano? E certo un Calamandrei rappresenta anch’egli assai bene quel radicalismo anticlericale e filo-socialista che fu l’azionismo, in cui s’illustrarono personaggi di alto rigore morale ma di altrettanto grande disprezzo per il cattolicesimo italiano come Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Ferruccio Parri, Altiero Spinelli, Raffaele Mattioli, Luigi Salvatorelli, Alessandro Galante Garrone, Ugo la Malfa, Giovanni Spadolini. Forse – mi sia consentito il dubbio sulla non perfetta correlazione fra le loro fortune culturali e accademiche e la loro effettiva levatura intellettuale – tutti brillanti intellettuali, ma quanto distanti dall’ethos popolare del loro Paese... E Habermas? uno degli esponenti della Scuola filosofica di Francoforte e «padre» del Sessantotto tedesco, nonché teorico di patriottismo costituzionale algido e irreligioso? Infine, la classica «ciliegina sulla torta»: che dire di Rousseau, padre della corrente più radicale della Rivoluzione francese, il cui pensiero – non lo dico io – è alle origini dei totalitarismi moderni?
Davanti a questa avocazione di paternità le perplessità sulla proposta finiana diventano pesanti come macigni. Il Risorgimento è infatti ora e sempre uno spartiacque culturale fra destra autentica e sinistra, fra conservazione e rivoluzione.
Se per Risorgimento intendiamo quell’idea secondo la quale l’Italia nell’Ottocento era civilmente «morta» – perché era troppo cattolica e perché ospitava il Papa-Re – e andava fatta risorgere attraverso iniezioni massicce di liberalismo e di democratismo, allora ci collochiamo nella prospettiva che è quella oggi l’ideologia ufficiale dello Stato nato nel 1861 e rinnovatosi nel 1945. Dunque una posizione che è difficile dire di destra. Se invece Risorgimento vuol dire indipendenza e unità politica degl’italiani ‒ o almeno di gran parte degl’italiani ‒, ovvero perfezionamento di un processo identitario che non nasce con l’unificazione stessa, la quale è di suo continuità, non rottura, con un passato glorioso, allora anche chi è di destra può riconoscersi in questa accezione.
Purtroppo ha vinto il Risorgimento nel primo significato, si è costruito cioè un habitat comune escludendone la maggioranza degl’italiani, non solo come cittadini, ma anche come depositari di una cultura resa subalterna. E non si dica che con Sturzo e poi la Dc tutto è cambiato: i cattolici hanno accettato lo Stato liberale e la Repubblica sospinti da quella frangia del democratismo sociale che non voleva rinunciare alla fede, ma che condivideva in pieno le idee del 1789 e la cultura e il processo risorgimentali ‒ ricordo ancora nitidamente con raccapriccio le parole con le quali il Presidente democristiano della Repubblica Giovanni Leone rivendicava con orgoglio la sua filiazione intellettuale dal conterraneo giurista, grande teorico del diritto ma anche rigido persecutore della Chiesa meridionale, Pasquale Stanislao Mancini ‒ e accettava di buon grado il ruolo marginale assegnato al cattolicesimo nella sfera economica, finanziaria, mediatica, accademica.
Quindi, se per essere patrioti bisogna riconoscersi in una costituzione ideologica, riconoscersi in Mazzini e compagni, e amare il Risorgimento anticattolico, allora preferisco un altro patriottismo, quello fatto di terra, di padri, di antenati, di valori ereditati.
È davvero sorprendente come oggi non si capisca, anche in alto loco, che reiterare stereotipi come quelli risorgimentalisti agitati da Fini non fa bene, in primis perché nega verità storiche ormai acquisite. Poi perché divide, non tanto ormai i cattolici dai laici, ma gl’italiani fra loro, perché impedisce di costruire una memoria autentica e integra, quella memoria riconciliata che è il necessario punto di partenza di ogni iniziativa volta a ristabilire e a rilanciare l’unità del Paese. Una «divisività» che si riverbera drammaticamente sulla dialettica politica odierna, trasformandola in lotta ideologica, con le ricadute miserevoli cui assistiamo in questi mesi. Invece di agitare vecchie cariatidi ideologiche, bisogna, stavolta sì, «fare gl’italiani», ridar loro il senso profondo della partecipazione politica, la fiducia in una politica che è ideale, progetto, ma anche interesse. Ma ancor prima occorre rifare la classe politica e cambiare le regole di base della vita politica democratica, evitando carte fondamentali piene di luoghi comuni ideologici e puntando invece a carte minimali, ma che rispecchino davvero la società italiana, i valori del popolo italiano e le sfide del futuro.
Ultima osservazione è quella sull’affermazione di Fini secondo cui «[…] la nazione [va] intesa come comunità politica in cammino. […] Il [cui] valore unificante e fondamentale è sempre lo stesso: la libertà».
La nazione, come detto, non è la comunità politica: la nazione la precede e ha il diritto di darsi la comunità politica, ovvero la forma-Stato e il regime, che ritiene più consono a se stessa. Fermo restando il valore della libertà ‒ e poi, quale? quella d’infilare una scheda in un’urna ogni cinque anni? quella di lavorare per almeno sei mesi all’anno per lo Stato? ‒, essa non è né l’unico né il supremo criterio di valutazione di un ordine politico. Vi sono altri criteri di pari e forse maggiore dignità: la verità, il bene comune, l’identità del popolo. Né si può appiattire l’appartenenza nazionale sulla cittadinanza statale o, peggio, farla dipendere dal riconoscersi in una Carta, mero strumento per migliorare il modo di essere governati – si veda la Costituzione americana – e di essere tutelati dallo Stato ‒ e non di tutelare lo Stato dal cittadino ‒ e non nuova edizione immutabile delle «tavole della legge» mosaiche. Una Carta, la nostra, per di più nata in un contesto molto diverso dall’attuale società italiana.
Nella presa di posizione di Fini in generale colpisce non solo l’alto tasso d’ideologia e di oleografia intellettuale che vi si riscontrano: in fin dei conti si sentono cose del genere da Napolitano e da altri pulpiti consimili e Fini ha anch’egli un ruolo istituzionale. Sorprende invece il poco spessore, la pedissequità con cui sposa modelli a lui finora estranei, la voluta indeterminazione – se non tout-court la vacuità – della terminologia, la poca veritatività del linguaggio: troppe parole a effetto, troppi luoghi comuni… Un gergo ossificato dietro cui s’intravede una dialettica gentiliana di terza mano, che rimanda, a sua volta, a una costellazione intellettuale e politologica di pari e forse maggiore vacuità.
Il mio è un giudizio troppo severo? vi è forse un disegno «discreto» e di alto profilo nazionale in Fini – come sostiene Giuliano Ferrara – che non colgo? Francamente davanti a una prosa come quella che ho cercato di riferire fedelmente – anche se in maniera forzatamente incompleta – e di chiosare e davanti al disegno intellettuale che ne emerge non si può non restare sconcertati e usare parole forti perché si tratta del disegno, che verrà applicato a un popolo, il mio. Se i miei timori si riveleranno infondati, e me lo auguro, lo diranno i fatti.