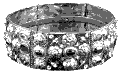"There died a myriad,
And of the best, among them,
for an old bitch gone in the teeth,
For a botched civilization,
Charm, smiling at the good mouth,
Quick eyes gone under earth's lid,
For two gross of broken statues,
For a few thousand battered books" (1)
Ezra Pound
Sul centenario del primo conflitto mondiale inizia già a scorrere l’inchiostro, come si diceva una volta, quando l’inchiostro era il mezzo di divulgazione privilegiato. Ma oggi potremmo aggiungere che all’inchiostro si vanno affiancando una sempre più ricca messe d’immagini — l’unico limite invalicabile è il bianco e nero delle fotografie e dei filmati d’epoca, insieme alla mancanza di colonna sonora —, una crescente profusione di parole e d’interpretazioni, e la esibizione di una sfilza di cimeli via via più ricca. Ma siamo appena agl’inizi: i fuochi d’artificio sono in programma più avanti e per il nostro Paese necessariamente non prima del maggio del prossimo anno. Per ora il motivo che domina le rievocazioni pare essere poco l’oleografia patriottarda che si respirava sulle piazze — popolate di malinconici monumenti ai caduti, con vuoti proiettili di artiglieria al posto delle colonnine — e nelle scuole italiane fino agli anni 1950, che dipingeva la guerra come un glorioso, ancorché malauguratamente cruento, estremo conato di Risorgimento. Dico "per ora" perché non si sa che cosa accadrà quando l’Italia "ufficiale" scenderà in campo, visto che il mito dell’"terzo Risorgimento" — il quarto posto è riservato alla Resistenza — è ancora tenacemente parte integrante del "pacchetto" di temi e di valori da cui invocano legittimità le odierne istituzioni patrie e peraltro si è visto che cosa è circolato in occasione del centocinquantesimo dell’Unità.
Oggi più palpabilmente l’accento pare venga posto sulla pace fra i popoli come valore supremo, dimenticando quasi sempre che la pace è sì un valore, ma un valore chi si attua come frutto, come "opus", come insegna la tradizione classica — "opus iustitiae pax" —, dello sforzo razionale di attuare la giustizia: un risultato che si conquista con fatica e talora sacrificando le proprie ragioni, una realtà sempre fragile e provvisoria in hac lacrimarum valle, da conservare gelosamente una volta raggiunto. Basta scorrere il lungo elenco dei titoli dei messaggi che i pontefici da ben quarantasette anni a questa parte indirizzano ai cattolici e agli uomini "di buona volontà" in occasione delle Giornate Mondiali della Pace per rendersene conto: titoli che esprimono altrettante condizioni — per lo più tutte disattese e, comunque, non facili da determinare — e non tutte di ordine materiale perché vi sia la pace: la giustizia, la libertà religiosa, la custodia del creato, la lotta alla povertà, l’unità della famiglia, il dialogo, il rispetto della persona umana, il rispetto della verità.
La Grande Guerra è un fenomeno storico apparentemente "chiuso": i cannoni non sparano più; i suoi protagonisti e vittime hanno ormai da tempo raggiunto la pace eterna; tantissima acqua è scorsa sotto i proverbiali ponti e tanti altri orrori hanno atto impallidire la sua memoria. Eppure riaprirne il dossier è per lo storico ogni coinvolgente, riveste un certo fascino: leggere della Grande Guerra non è la stessa cosa che leggere delle guerre puniche o del bellum gallicum. Se è vero che lo storico si accosta al passato perché gli interessa il presente — e il futuro —, allora evidentemente qualcosa di attuale il ricordo del lontano conflitto europeo ancora smuove, qualche propaggine estrema di essa, qualcuna delle ligne de force che l’hanno scatenata e animata, è ancora, sebbene carsicamente, vivo e attivo nel sottofondo del mondo odierno. La guerra 1914-1918 è il primo conflitto compiutamente moderno e la modernità, sebbene in declino, è tuttora l’"ambiente", la dimensione, in cui si snoda la vita dell’uomo contemporaneo. Così, ripercorrere quella vicenda ormai lontana, riannodare a essa i fili che da essa scaturiti le collegano il mondo di oggi, aiuta a mettere meglio a fuoco la realtà contemporanea. Ha, in altri termini, una valenza maieutica — come cartina al tornasole, come chiave di lettura, come monito — tuttora valida ed efficace, completando, unita ai successivi, la catena degli eventi che è alla radice della condizione attuale.
Piuttosto che condannare aprioristicamente il terribile conflitto scoppiato cento anni or sono esatti — cosa peraltro non oziosa —, pare utile cercare di capire che cosa fece saltare allora in maniera così clamorosa e devastante gli equilibri costruiti dallo sforzo di generazioni di uomini nei decenni precedenti. Scoprire cioè che cosa allora congiurò contro la pace; individuare e descrivere i fenomeni che fecero sintonizzare il mondo di allora su una frequenza d’onda nuova e cacofonica; quale fu il "moltiplicatore", il volano, che creò il cataclisma; cercare ciò che venne meno, che crollò, nelle strutture profonde del Vecchio Continente, avviandolo verso una palingenesi dopo la quale "nulla sarà come prima". Si tratta, come evidente, di un lavoro lungo e impegnativo, che non si può pensare di esaurire in un articolo, se non allestendo una bozza di indice, un elenco sommario di temi, fatti, letture che possa aiutare a mettere a fuoco la genesi e lo sviluppo dell’evento bellico, a contestualizzarlo e a renderlo, di conseguenza, meglio comprensibile.
Non che poi il giudizio non debba essere comunque di condanna: tuttavia vederne le radici aiuterà quanto meno a evitare di ripetere gli errori e di rinnovare le colpe — che fuori di dubbio vi furono e non poche — dei nostri — almeno per la mia generazione ormai anziana — nonni.
1. Cento anni di pace inquieta
La prima guerra mondiale scoppia a cento anni esatti dalla fine del ciclo delle guerre "napoleoniche" che a partire del 1792 ha devastato in maniera mai sperimentata prima, neppure al tempo della tremenda Guerra dei Trent’anni (1618-1648), il Vecchio Continente.
Il 1814 segna infatti il crollo dell’impero europeo e "profano" creato dal generale Bonaparte (1769-1821), una realtà che, anche dopo la parentesi dei Cento Giorni e la debole riedizione di Luigi Napoleone (1808-1873), non tornerà più. Sei mesi dopo la battaglia di Lipsia dell’ottobre del 1813, sotto i colpi delle armate coalizzate — Prussia, Russia, Austria e Inghilterra — cade Parigi; nello stesso 1814 gli spagnoli cacciano i sovrani napoleonidi e rimettono sul trono, con l’aiuto inglese, i Borbone; l’effimero granducato polacco viene dissolto; il Regno d’Italia nato nel 1805 si sfalda; nei regni più piccoli tornano gli antichi sovrani. La carta politica d’Europa, apparentemente, torna a ricalcare gli assetti prerivoluzionari.
Ma non è così: non è così nella sostanza, perché l’antica frammentazione e disomogenetità dei principati conoscono una drastica semplificazione e perché non pochi dei cambiamenti nei rapporti sociali ed economici e negli assetti amministrativi introdotti dalla dominazione francese vengono mantenuti, vuoi per ragioni di maggiore efficienza, vuoi per l’irrestaurabilità delle condizioni precedenti il 1789, vuoi, infine, perché i regimi restaurati sono assai parchi di purghe anti-bonapartistiche e anti-"giacobine" e molto del personale dei cessati regime viene lasciato in carica, al solo prezzo di smussare in certa misura le antiche idee libertarie.
Al Congresso di Vienna, apertosi ufficialmente il 1° novembre 1814, quando Napoleone è confinato all’isola d’Elba in attesa di dar vita alla "fiammata" imperiale dei Cento Giorni e sta per andare incontro al suo tracollo definitivo a Waterloo, approda una Europa esausta, ferita e disillusa dal sogno imperiale francese che si è tradotto in venti anni d’ininterrotti conflitti fra le potenze europee — solo la campagna di Russia del 1812 produrrà circa mezzo milione di morti —, profondamente "lavorata" dalle dinamiche messe in atto dai governi influenzati dalle idee della Rivoluzione, e in cerca di nuovi e più stabili equilibri. E il consesso della diplomazia europea, nonostante le non poche carenze, farà sì che per un lungo periodo, almeno fino alla frizione franco-austriaca e austro-prussiana della seconda metà del secolo, gli eserciti europei rimangano chiusi nelle caserme.
Il secolo di pace, o almeno di assenza di guerra generalizzata fra gli Stati, che si apre nel 1815 e che dura fino alla prima guerra mondiale è però tutt’altro che un secolo di quiete.
2. Una Europa "instabile"
Le idee del 1789, sconfitte in apparenza dal crollo dell’impero della Grande Nation, continuano infatti a fermentare producendo a più riprese, nei primi decenni del secolo, sommovimenti politici neo-bonapartistici e democratici. Ma questi conati revanscisti falliscono e le idee rivoluzionarie che hanno animato il periodo repubblicano e napoleonico, tendono a ripresentarsi sotto altra veste: mentre il trinomio rivoluzionario — l’"ortodossia" — rimane coltivato da pochi fedeli, l’illuminismo "astratto" cede il passo al romanticismo e la fraternité cosmopolita della Rivoluzione alle tradizioni — non di rado "inventate" — nazionali. Romanticismo e nazionalismo sembreranno ai rivoluzionari "puri" un revival assolutistico, un ritorno, al passato, ma si tratterà solo di una metamorfosi "strategica" che le grandi spinte ideologiche createsi nel Settecento attuano. Nell’Ottocento le dinamiche rivoluzionarie non affrontano più di petto i residui "feudali" — impresa fallita con Bonaparte —, bensì attaccano l’ordine postrivoluzionario attraverso il solvente del nazionalismo e del liberalismo: il primo mira a dissolvere gl’imperi assoluti e a unificare i "piccoli Stati", forgiando degli Stati-nazione — in attesa, però, di poter dar vita a nuovi coaguli sovranazionali democratici e "profani" come la Grande Nation o gli Stati Uniti d’America —, l’altro a realizzare la liberté non più in un’ottica "giacobina", ma rifondando il "dogma" della sovranità popolare sull’esperienza storica delle nazioni. A ben osservare, il rapporto fra i due termini non è paritetico: se il "vettore" è rappresentato dal nazionalismo, l’"idea di nazione" — concepita secondo paradigmi moderni, ergo falsata — è spesso la chiave o il pretesto per facilitare a minoranze "illuminate" il compito di costruire ordinamenti costituzionali moderni, come si vede nitidamente nel Risorgimento italiano, in cui il motivo indipendentistico-unitario serve alla borghesia liberale e al Piemonte sabaudo per costruire uno Stato non solo unitario, ma anche moderno (2). Lo Stato-nazione è in effetti una realtà del tutto sconosciuta all’età antica e all’età della cristianità e inizia a prendere forma, non casualmente, nell’Europa del Cinquecento, quando nascono le monarchie, sì "composite" (3), ma già accentrate e in via di differenziarsi su base nazionale: da allora in poi si tenderà sempre più spesso a parlare di "monarchia francese", "inglese", anche se il tasso di similitudine con gli Stati del XX secolo è all’epoca ancora modesto.
Al di sotto e spesso in concomitanza con la formazione delle nazioni moderne, il processo di gran lunga più importante e duraturo, ancorché meno visibile, impressionante per diffusione e successi, è la costruzione di Stati moderni, ovvero di compagini politico-territoriali formalizzate, burocratizzate, sempre più "desacralizzate", che si arrogano il monopolio della forza e il diritto-dovere di espletare un numero sempre più elevato di funzioni sociali (4).
Il nazionalismo, la dominante del secolo, combinandosi con quest’ultimo processo, assumerà due volti: uno scompositivo/riaggregativo, più presente nella prima metà del secolo, sostanziato dalla lotta che varie entità nazionali — concepite tuttavia secondo moduli ideologici moderni —, in Europa e altrove, conducono con mezzi diversi, pacifici e non, per organizzarsi in Stati autonomi — dall’Austria, dalla Sublime Porta, dalla Russia, dalla Gran Bretagna —; e l’altro competitivo/aggressivo, che matura verso la fine del secolo, che spinge, in nome del "sacro egoismo" (5), alla competizione fra nazioni — e nazionalismi —, specialmente fra nuovi Stati e "vecchi" Stati — basti pensare all’Italia e ai Balcani —, che, nell’assetto eurocentrico-coloniale del mondo di fine-Ottocento, li mette in antagonismo fra loro non solo sul suolo europeo, ma anche in quello che diverrà il secolo successivo il Terzo Mondo.
In entrambe le vesti, da un certo punto di vista — diverso da quello che elogia la prima e condanna la seconda di queste due derive —, il nazionalismo moderno riveste un carattere strumentale — al servizio delle élite innovative e degli Stati — e sarà nitidamente un driver e un catalizzatore di "rivoluzione". L’amor di patria (6) è una costante nella vita collettiva e dei popoli, ma, altresì, sovente uno strumento della politica, usato per mobilitare gruppi e masse: storicamente, in Età Moderna, prima è fatto coincidere con l’amore per il sovrano e la dinastia, poi giustificato con la "ragion di Stato"; ora, nel secolo XIX, associato ai "diritti" di una "nazione" — concetto dall’essenza maldefinita o intesa ideologicamente — per essere più tardi abbandonato a favore del patriottismo di classe e per tornare, infine, al servizio della lotta "anti-imperialistica" nei teatri del Terzo Mondo.
Il politologo federalista Mario Albertini (1919-1997) istituirà addirittura un rapporto di sudditanza fra nazione e Stato moderno, affermando che il nazionalismo non sarebbe altro che l’ideologia specifica dello Stato centralizzato e burocratico moderno (7). Mentre il politico moravo, nonché alto dignitario massonico, Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) affermerà serenamente che la nazione costituisce "[…] una delle forze potenti della democrazia" (8). Anche lo storico francese Daniel Halévy (1872-1962) non ha dubbi in proposito: "[…] nel 1929 […] dopo aver notato la rassemblance frappante tra i concetti di guerra e rivoluzione, e la difficoltà di distinguere, in molti casi, tra una rivoluzione ed una guerra […], Halévy aveva aggiunto che tutte le grandi convulsioni dell’Europa moderna erano state al tempo stesso guerre e rivoluzioni: la guerra dei Trent’anni come la grande guerra […] del 1792-1815 contro Napoleone" (9).
* * *
Nel 1878, all’indomani del Congresso di Berlino, se molti degli uomini che sono stati artefici del processo di cambiamento che ha luogo nella prima parte dell’Ottocento, si possono sentire appagati — è forse questa la condizione della Destra Storica in Italia dopo il 1870 —, l’assetto che l’Europa conosce all’alba del decennio 1880, sotto l’apparente irreversibilità del quadro, si rivela fondamentalmente instabile.
Il nazionalismo, una volta scatenato contro gl’imperi assoluti, diventa un soggetto assai difficile da controllare e da dosare. Inoltre, i regimi nati dai vari risorgimenti o dalle varie riforme liberali sono regimi fortemente classisti, che si scontrano presto con il movimento operaio e il socialismo; le loro classi dirigenti, grazie al suffragio ristretto, sono ridotte di numero e la maggior parte della popolazione, come in Italia, resta esclusa dalle decisioni politiche; quasi ovunque non è stata realizzata una coincidenza perfetta fra confini ed elemento etnico, sì che molti Stati "nazionali" incorporano consistenti minoranze "irredente"; infine, le classi dirigenti liberali e democratiche si contrappongono, talora in maniera radicale, alla presenza religiosa nella società. In più il sentimento di appartenenza collettivo delle nuove entità statali create dai vari processi risorgimentali risulta per svariate cause alquanto tenue, specialmente nelle classi rurali che, a quel tempo, sono ancora l’elemento maggioritario nella società, mentre le politiche interne di "nazionalizzazione", spesso condotte con intransigente determinazione, alimentano nuovi conflitti non di rado "trasformati" in conflitti con i popoli vicini.
I Paesi europei, nonostante l’aspetto vistosamente conservatore dei vertici — pennacchi ed elmi continueranno a rifulgere lungo tutta la Belle Epoque —, sono attraversati da intensi processi di cambiamento, che poco spazio trovano nelle cronache, ma i cui effetti sono estremamente potenti: la rivoluzione industriale, che conosce progressi sbalorditivi proprio al volgere del secolo; la secolarizzazione della società — che trova il suo emblema nella separazione fra Stato e Chiesa —; lo sviluppo in senso naturalistico e materialistico delle culture, specialmente quella delle élite urbane, che si traduce in generale, nel pensiero e nelle arti — nonostante l’esplosione dell’idealismo crociano —, in un ulteriore e sempre più multiforme distacco dalla forma mentis classico-cattolica e dalla prospettiva religiosa della vita.
Si tratta di dinamiche apparentemente neutre, "meccaniche" e "trasversali", ma lo sono solo in parte: se da un lato il progresso delle scienze naturali e delle tecniche e la sua ricaduta sugli apparati produttivi e le comunicazioni paiono avere un quid d’ineluttabile, esso in realtà è sostenuto da una "portante" culturale ineliminabile: non si spiega solo con l’evoluzione della scienza o con le esigenze cieche dei "mercati", bensì con la trasformazione che ha luogo nella cultura delle élite, con il formarsi, sempre più diffusa, di una mentalità — faccio coincidere solo argumentandi causa la nozione di cultura con quella di mentalità — sempre più imbevuta d’idee positivistiche e materialistiche, nonché con il crearsi negli Stati moderni di fabbisogni sempre più ingenti di risorse in coerenza con il loro enorme sviluppo dimensionale e strutturale. A riguardo si può parlare di un circolo assai poco "virtuoso", in cui la cultura alimenta il progresso materiale, il quale, a sua volta, retroagisce sulla cultura. E non si tratta sempre, in entrambi i versi, di un influsso benefico…
* * *
Fuori di dubbio, dopo aver conseguito l’unità nazionale sotto l’egida del regno prussiano, moderatamente accentrato e liberale, i popoli germanici hanno prodotto uno sforzo di crescita straordinario, che si estende dall’industria alla tecnica, dalle esplorazioni geografiche alle scienze umane, dalla potenza militare alla scuola. I prodotti industriali tedeschi raggiungono a inizio-secolo livelli di qualità riconosciuti unanimemente, l’amministrazione del Reich è retta ed efficiente, l’esercito e la marina germanici sono i più avanzati del Continente, le università laiche e religiose le prime del mondo, il progresso nella ricerca scientifica, nelle scienze naturali e nelle discipline umanistiche sensazionale. La Germania post-bismarckiana ha tutti i numeri per avviarsi con piena legittimità a rivestire un ruolo di supremazia fra gli Stati e i popoli del Vecchio Continente.
Questo trend — come detto — non è tuttavia visto con simpatia dalla Gran Bretagna, gelosa del suo dominio sui mari che il potenziamento della flotta tedesca inizia a mettere in discussione, e intesa da sempre a impedire la nascita di potenze dominanti nel Continente. Si può anzi dire che la nascita stessa di un potente blocco centro-europeo austro-germanico, al di là del suo atteggiamento, diventa un problema per la politica estera inglese fin dagli anni Ottanta del XIX secolo.
Così pure la Francia, la nemica di sempre della Prussia — divenuta ormai la Germania — e ansiosa di vendicare le sconfitte patite nel 1870, vede nella crescita tedesca un ostacolo sempre più insormontabile in vista del ricupero delle province renane perse da Napoleone III (1808-1873). La Russia, poi, non esistendo lo Stato polacco, si trova a confinare direttamente a occidente con il Reich e teme, a buona ragione, la tradizionale spinta germanica nach Osten, verso oriente, e verso il Lebensraum, un più ampio "spazio vitale", quello che diverrà negli anni 1930 il Leitmotiv della politica del Terzo Reich e una delle cause dello scoppio del nuovo conflitto mondiale.
* * *
Nell’inventario delle aree di tensione esistenti nel quadrante europeo non può mancare la zona renana. L’Alsazia e la Lorena, regioni a forte maggioranza germanica, sono state riconquistate dalla Prussia alla Francia nel 1870 e integrate, in forma paritetica con gli altri Stati, all’interno del Secondo Reich. Si tratta di aree mistilingui e storicamente fluttuanti fra corona francese e Stati germanici, che il nazionalismo francese all’alba del XX secolo rivendica in maniera fanatica, quasi mistica, fondandovi sopra l’essenza della nazione ed estendendo — in maniera più o meno abusiva — l’irredentismo fino a contaminare i programmi della destra patriottica ma dottrinalmente non nazionalista, come rivelerà la vicenda, a tratti drammatica, dell’Action Française. Ma il revanscismo della repubblica francese, quanto meno sotto l’aspetto politico-militare, si è all’inizio del secolo sensibilmente attenuato e solo lo scontro con la Germania causato dall’alleanza con la Russia varrà a riattizzarlo ferocemente.
* * *
Sepolta appare invece l’antica conflittualità fra il Reich e l’altro Stato a egemonia etnica germanica, l’Austria-Ungheria. Fra le due potenze imperiali centro-europee resta solo come elemento di disturbo il vecchio sogno, coltivato da alcuni circoli intellettuali e politici, di un unico Stato dei tedeschi, che sarà coronato nel 1939 da Hitler con il brutale Anschluss di un’Austria ridotta ai minimi termini. I due Stati, anzi, stretti da alleanza militare, formano sempre più un forte e coeso blocco al centro dell’Europa, dal Mar Baltico all’Adriatico, e hanno più di un motivo, non solo ideologico, per seguire politiche di mutua cooperazione e strategia. Solo quando il conflitto mondiale volgerà al peggio per loro, allora riaffioreranno le vecchie differenze religiose, strategiche e politiche e i vecchi antagonismi: ma i loro soldati combatteranno fino all’ultimo a fianco a fianco, in totale solidarietà, nei vari teatri di guerra. Non si sa quanto alta sia al momento della stipulazione dell’alleanza fra Austria-Ungheria e Germania la consapevolezza del rigetto che l’asse franco-inglese-russo coltiva riguardo al sorgere di una potenza che — con l’aggiunta del Regno d’Italia — taglia in due dall’alto al basso il Vecchio Continente. Come rivelerà il conflitto si tratta, tuttavia, di una potenza autenticamente poderosa sotto il profilo industriale e militare che però presenta la debolezza, appunto, di essere circondata da potenze in tesi poco amichevoli, con il rischio, come poi tragicamente accadrà, di potersi trovare a combattere su due fronti, entrambi di estensione gigantesca.
La monarchia asburgica ha ormai da tempo spostato il suo baricentro verso gl’inquieti Balcani. Nel 1878 ha strappato all’Impero Ottomano la Bosnia-Erzegovina, autentico calderone di nazionalità e religioni. Con questa acquisizione le nazionalità slave e le religioni cristiano-ortodossa — obbediente al patriarcato di Mosca — e musulmana acquistano così maggior peso all’interno dell’impero a scapito delle altre due etnie, quella germanica e quella ungherese, anch’esse tuttavia in tradizionale contesa fra loro. La forte minoranza ebraica — quasi due milioni di persone —, per lo più importata dai territori già polacchi, è pienamente integrata sul piano giuridico e, nonostante periodi di tensione popolare, non costituisce un problema di primo piano, anzi, come in altri Paesi, l’elemento ebraico domina il mondo intellettuale, economico e delle professioni, contribuendo al progresso dello Stato asburgico e darà anch’esso il suo contributo di sangue nel conflitto.
L’impero austroungarico coltiva da tempo contenziosi territoriali con i regni periferici orientali, la Bulgaria e la Romania, ma percepisce sempre più forte la minaccia del regno serbo, non tanto sotto il profilo diplomatico-militare — peraltro da non sottovalutare, visti i legami storici e culturali fra Serbia e Russia zarista —, bensì, un po’ come il Piemonte fra 1849 e 1859, quanto alla possibilità che esso diventi la ridotta, il "santuario", il motore di tutti movimenti nazionalistici e panslavistici balcanici, nemici dichiarati della formula sovranazionale della Duplice Monarchia.
Nella questione degli slavi, come pure in Polonia e, in generale nei Balcani, l’Austria-Ungheria, dopo l’Anschluss della Bosnia, si trova a sostenere il pesante antagonismo della Russia zarista, che considera la Serbia come il cuneo della potenza slavo-ortodossa inserito nel mezzo dei popoli cattolici centro-europei.
Vienna ha osservato la spregiudicata politica serba nel corso delle due guerre balcaniche del 1912-1913 e coltiva il timore che il rapido sfacelo del contiguo impero ottomano — di cui pure ha beneficiato — rappresenti un possibile e non remoto rischio anche per lo Stato asburgico qualora le ambizioni del regno vicino non siano drasticamente ridimensionate. Per l’Austria la Serbia diventa così sempre più "il" nemico.
Diverso è il discorso nei riguardi dell’Italia, fino all’ultimo alleata dell’Austria-Ungheria nella Triplice: l’irredentismo italiano è per la monarchia asburgica un pericolo reale, ma incomparabilmente minore di quello slavo e, comunque, pur tradizionalmente radicato nell’ideologia risorgimentale e nazionale, è allora un elemento programmatico di circoli tutto sommato secondari della politica italiana ed è poco presente a livello popolare, come dimostrerà l’adesione di decine di migliaia di trentini e di veneti giuliani al reclutamento austriaco quando scoppierà il conflitto — essendo sudditi austroungarici già quindi nel 1914 — e durante la sua consumazione, combattendo per lo più sul fronte orientale e meridionale.
* * *
La Grande Guerra sarà dunque il momento in cui cambiamenti travolgenti in cerca di nuovi equilibri, antiche rivalità di potenza giunte al parossismo e i frutti velenosi dei vari nazionalismi e delle teorie nazional-egemoniche — pangermanismi, panslavismi, panrussismi e panturanismi (quello turco) — si combineranno fra loro catalizzandosi a vicenda e le potenze decideranno di procedere a un "regolamento di conti" a lungo rimandato.
Il dramma sarà che tutte queste forze impazzite cercheranno la resa dei conti non come nel secolo precedente, bensì in un modo nuovo e più moderno — ergo più devastante —, usando tutta la potenza materiale — così cresciuta al punto di renderne stupefatti gli stessi che se ne avvarranno — che il secolo del Ballo Excelsior, del mito del progresso tecnico, offriva loro per fare la guerra.
* * *
Limitandosi alle frizioni nazionalistiche — e scartando le concause politico-materiali della guerra, meno immediate, e trascurando del pari le rotture più remote degli equilibri internazionali, come quelle della guerra russo-giapponese del 1905 e della guerra italo-turca in Libia nel 1911-1912 —, il terreno di coltura principale del conflitto mondiale sembra sempre più chiaramente essere stato quello slavo-balcanico.
La guerra contro la Serbia viene intrapresa da Francesco Giuseppe (1830-1916) come una risposta di forza alle provocazioni del vicino Stato, a tutti gli effetti quindi nell’ottica — ultrariduttiva e ultrarischiosa — di una terza guerra balcanica. Scrive lo storico Graziosi: "La vittoria contro [l’impero ottomano], e poi quella contro gli ex alleati nella lotta per la divisione delle spoglie, aveva […] esaltato il nazionalismo serbo che, dopo le vittorie a sud, rivolse la sua attenzione e le sue energie alla soluzione del problema serbo a nord, vale a dire contro la presenza austriaca in Bosnia" (10). L’insidia serba, considerata con un misto di autosufficienza e di terrore da parte delle élite asburgiche, verrà tuttavia affrontata con una durezza eccessiva, che provocherà la catena delle mobilitazioni e delle dichiarazioni di guerra che porterà al conflitto su scala europea.
Le altre questioni sul tappeto — di cui ho fornito un telegrafico inventario — esploderanno solo come contraccolpi del conflitto austro-serbo. Ma, una volta appiccato l’incendio, tutti gl’interessati, dalla Francia all’Inghilterra, dalla Germania alla Russia, dall’Italia alla Romania, dai polacchi ai boemi, dai bulgari ai greci, dai sionisti ai bolscevichi, cercheranno di alimentarlo e di approfittarne per attuare la propria agenda. Peccato che collettivamente abbiano sottovalutato i costi prossimi e remoti del raggiungimento dei loro obiettivi.
3. Grande Guerra e Rivoluzione
Lo scenario che ho abbozzato parte, come si è visto, dalla Rivoluzione francese. Ed è incontestabile (11) che la frattura che ha luogo allora scateni una colluvie di processi storici che si sviluppano a colpi e a contraccolpi, con velocità diverse e modalità non sempre identiche lungo tutto il secolo XIX. La prima guerra mondiale, in questa prospettiva, non si può concepire come un evento a sé stante ma va vista all’interno di un continuum di eventi storici almeno secolare.
Ma, il 1789 e i suoi sviluppi ottocenteschi si possono considerare una realtà originaria e compiuta? Oppure, a loro volta, sono la conseguenza, il punto di sbocco, di altre dinamiche, segnate da altri eventi-chiave, a essi antecedenti? Il "lungo Ottocento"— così il secolo viene definito, in contrapposizione al Novecento "breve" — è un unicum, un processo autoreferenziale e "chiuso", il fall-out di una ben precisa e unica eruzione vulcanica conclusasi appunto con la Grande Guerra, oppure scaturisce da una fonte più "a monte" e il suo corso si svolge ben oltre la cronologia dell’evento bellico?
Pare assodato che quanto prende avvio nell’Ottantanove francese sia in realtà il portato, il punto di sbocco di circa tre secoli di mutamenti indotti dal fenomeno della modernità. Con questo termine intendo quel processo che prende le mosse nel momento in cui la civiltà medievale esaurisce la sua "spinta propulsiva" e, pur attraverso non pochi mutamenti nelle forme, giunge fino a noi. Quindi "modernità" non è solo una mera periodizzazione della storia europea, ma un fenomeno pluriforme di culture change teso a rivalutare l’uomo come centro del creato e dell’universo e a comprimere o ricollocare al giusto posto quei principi e valori troppo sottovalutati nei secoli del Medioevo. Di esso si possono distinguere almeno due "anime": l’antropocentrismo che si pone in continuità con le dottrine medievali, ma vuole purificarle dagli eccessi sacralizzanti e dalle incrostazioni storiche temporalistiche, e il simultaneo — e vincente — tentativo consapevole di alcune minoranze "illuminate", non solo di ricollegarsi con il passato, riconducendo ad pristinum il rapporto dell’uomo con Dio e con il mondo, bensì di rompere con il passato, di ridefinire completamente i confini di tale rapporto e di mutare le coordinate del pensiero e della morale, rinnovando i fasti della cultura classica precristiana: in altre parole di attuare una Rivoluzione, ovvero a operare un cambiamento radicale nominalmente inteso a riportare — "revolvere", "rotolare indietro" —, saltando i secoli della cristianità, la civiltà umana a origini tanto felici quanto mitizzate.
La Rivoluzione francese è l’evento che segna — come una sorta di punto di non ritorno — il debordare di questa dinamica dalla sfera della cultura religiosa e intellettuale e dei costumi alla sfera della politica, cambiando non solo le visioni del mondo ma gli ordinamenti dei popoli.
Nel Cinquecento e nel Seicento la modernità politica ha dato vita a grandi Stati monarchici sempre più accentrati e dispotici, attraverso i quali ha operato la conquista all’Occidente di interi continenti, creando immensi imperi globali come quello spagnolo e estendendo la civiltà europea ai popoli di tutto il mondo (12). Alla fine del Settecento il progetto della modernità non si accontenta più di aver sepolto la cristianità, né di aver cambiato il senso comune — illuminismo — e i costumi — libertinismo — delle classi dirigenti della società attraverso le logge, le accademie e le "società di pensiero", ma vuole — è l’ora dei club e dei partiti —scolpire tavole di valori opposte a quelle tradizionali, distruggere le antiche gerarchie sociali, forgiare nuove forme di governo, con l’implicito proposito di rendere irreversibile — trasfondendolo in istituzioni — il "progresso" e, nel contempo, di "socializzarne" le conquiste, portandole alle masse.
Nell’Europa del tardo XVIII e del XIX secolo questo processo conosce appunto una fase nuova, seconda rispetto al Rinascimento, alla Riforma protestante e all’età dei primi imperi coloniali. Ma, a sua volta, solo antecedente, cronologicamente e nei contenuti, rispetto a una terza fase, che proprio il primo conflitto mondiale apre: quella della Rivoluzione sociale e socialista, che investe non solo gli ordinamenti politici, ma vuole agire principalmente — non che dimentichi l’ambito "religioso" e quello "politico", anzi… — in quella trama più fine e profonda che sono i rapporti economici e sociali, la produzione dei beni e le classi. Se nella fase pre-Ottantanove il bersaglio principale della Rivoluzione è la Chiesa e nella fase successiva è il re, in quella socialista saranno il pater e la proprietà privata. Questa "terza" Rivoluzione, destinata a impregnare di sé il XX secolo, avrà come evento-simbolo non più le tesi di Lutero, non più la presa della Bastiglia o il regicidio, bensì la Rivoluzione di Ottobre del 1917 (13).
La Grande Guerra, tipico esempio storico di eterogenesi dei fini, rappresenta la cerniera fra due mondi, il "salto qualitativo", il veicolo che traghetta il mondo dei "notabili" liberali, dei re costituzionali, dei residui imperatori assoluti, del dominio della borghesia industriale e rurale, a un mondo de-gerarchizzato e sbriciolato, dove dominano la democrazia e i totalitarismi, la finanza cosmopolitica e le potenze extra-europee, le ideologie moderne e il secolarismo, i "modernismi" e gli antisemitismi, prospettive di civiltà di massa e utopie — allora, oggi realtà — tecnocratico-elitarie, nazionalismi e disegni paneuropei.
* * *
A sottolineatura di quanto ho fin qui detto, s’impone un’ulteriore considerazione.
Nel XIX secolo e, soprattutto, nel XX secolo si osserva un fenomeno nuovo che dà un sapore caratteristico all’età contemporanea o, più precisamente, al secolo scorso.
Il marker più nitido dell’Età Contemporanea è la Rivoluzione: un processo di ininterrotta demolizione dell’"antico regime" e di edificazione di assetti collettivi basati sui diritti dell’uomo e l’uguaglianza. Ed è anche un periodo d’ininterrotti conflitti piccoli, medi e grandi: e questo perché la Rivoluzione — nel senso predetto — genera la guerra e la guerra genera rivoluzione. Le guerre dinastiche sono finite, gli Stati non si scontrano più con motivazioni di pura potenza come nella prima Età Moderna, bensì a partire da Napoleone ogni guerra ha uno scopo eversivo — di un segno o del segno opposto — e, al contrario, ogni disegno di "nuova società" di frequente — non esclusivamente, se pensiamo a Gandhi — tende ad realizzarsi attraverso la violenza.
Questo rilievo è uno degli assi portanti dell’argomentazione (14) — peraltro più ampia — di un contemporaneista di cultura post-marxista, specializzato in storia sovietica e dei Paesi dell’Europa orientale, Andrea Graziosi, già menzionato, secondo il quale, appunto, almeno a partire dal 1905, cioè dalla guerra russo-giapponese, e fino al 1956, l’anno della "crisi di Suez" e della rivolta di Budapest, gli eventi storici siano il prodotto dell’intreccio inscindibile di queste due realtà e la guerra null’altro che una modalità di incarnazione storica dell’idea rivoluzionaria. Non vi sono risorgimenti — basta pensare al nostro — e regime change senza guerre, né guerre senza ricadute politiche — basti pensare a Napoleone III o al nostro secondo dopoguerra. Riguardo alla guerra 1914-1918 Graziosi afferma che "[…] non è […] meno vero che […] la prima guerra mondiale fu sia una rivoluzione in se stessa sia l’avvio e la prima tappa di una rivoluzione di portata e dimensioni ancora maggiori, proseguita negli anni Trenta in apparenti condizioni di pace, e infine conclusa da un terzo atto che prese, ancora una volta, le forme di un enorme conflitto" (15). E cita una frase assai appropriata di Gioacchino Volpe (1876-1971), secondo il quale alla vigilia della Grande Guerra "[…] rivoluzione e guerra erano considerate dai più come diversa e opposta cosa, tanto che molti rivoluzionari si opponevano alla guerra come diversivo dalla invocata rivoluzione e, viceversa, come diversivo dalla deprecata rivoluzione molti conservatori la sollecitarono; rivoluzione e guerra si rivelarono ben presto, agli occhi dei più veggenti e poi nella realtà fattuale, quasi una cosa sola" (16).
Anche secondo la prospettiva empirica di uno storico "laico", dunque, l’evento-Grande Guerra s’inserisce con un ruolo proprio all’interno di quel grande processo di cambiamento storico-culturale, che si verifica all’interno della più generale "dialettica della modernità", che per molti ha nome di "Rivoluzione", e il cui Leitmotiv — al di là del giudizio di valore — è il passaggio dalla civiltà tradizionale, gerarchica e sacrale medievale alla società secolaristica e democratica contemporanea.
4. Lo "sbocco" del 1914
Tutto quanto ho fin qui detto serve a suffragare l’affermazione che ciò che accade nel 1914 viene da lontano, non è un fenomeno isolabile e rappresenta lo sbocco, ahimè violento, di una serie di contraddizioni maturate all’interno dei popoli europei quanto meno dal 1789 in poi.
Ma si tratta di uno sbocco fatale, meccanico, ineluttabile?
Nella storia non opera il Fato, ma sono attivi processi di carattere fisico-umano, che, una volta messi in moto, scatenano tutte le loro influenze e giungono a "decidere" in amplissima misura i comportamenti e le opzioni dei soggetti storici, facendo aggio sulla libertà umana che, in ultima analisi, è la dimensione non unica ma realmente determinante della storia. Per chi ha retto le sorti dei popoli in quei drammatici mesi che preludono al conflitto generalizzato, anche con le migliori intenzioni di questo mondo, pur potendolo, non è stato facile mantenere un distacco sufficiente per prevedere tutte le conseguenze di una guerra in tesi limitata come quella fra Austria-Ungheria e Regno di Serbia. Le élite del tempo, al di là delle opzioni personali, condividevano altresì una medesima forma mentis e possedevano una cultura politica comune. Ed erano, come accennato, da tempo e in profondità "lavorate" dai teoremi e dai valori della modernità, specialmente dalle pericolose teorie politiche di stampo evoluzionistico e materialistico, che coltivano l’idea della "superiorità" razziale delle nazioni occidentali e vedevano la guerra come "igiene del mondo". Una modernità — non dimentichiamolo — che allora sotto l’aspetto corrusco e "forte" dell’imperialismo "laico" e dell’industrialismo guerrafondaio nasconde già i germi della sua dissoluzione, come testimonia il diffondersi nella cultura delle nazioni del decadentismo, del nichilismo nietzscheano, del surrealismo, del pansessualismo freudiano: tutti elementi decisivi di quella "perdita del centro" o estinzione dell’anima dell’umanesimo europeo che culmina nel cosiddetto "postmoderno".
Nel 1914 le voci delle istanze morali superiori, specialmente quelle dei due papi che regnano quell’anno, Pio X (1835; 1903-1914) e Benedetto XV (1854; 1914-1922), non sono più ascoltate; non esistono autorità politiche internazionali come l’ONU; ogni potenza agisce autoreferenzialmente; la diplomazia tende a essere un’arma, piuttosto che uno strumento di conciliazione non violenta delle controversie fra Stati; l’orizzonte è diventato disperatamente naturalistico, regnano la forza materiale e la politica di potenza: ogni finalità che non sia il puro dominio attraverso la forza — magari in chiave di difesa dal dominio altrui — impallidisce e si eclissa.
5. Realpolitik e miopia delle classi dirigenti
Può lasciare interdetti vedere con quanta miopia gli uomini del 1914 non abbiano saputo intravedere la dinamica di cause-effetti che avrebbe portato da un conflitto regionale di breve durata a una guerra mondiale destinata a durare cinque lunghi e terribili anni. Una caratteristica, credo, che si riscontra presso quasi tutte le classi dirigenti che scelgono la guerra, tanto quelle maggiormente influenzate dall’ideologia, quanto quelle ispirate dalla Realpolitik.
Una catena che a noi oggi è ovvia ed evidente nella sua drammaticità, che allora di certo non poteva essere vista con la medesima limpidezza, ma che poteva e doveva quantomeno essere intuita. Dico "poteva" perché i mezzi di comunicazione del tempo — telegrafo, telefono, treni veloci, aeromobili — erano probabilmente sufficienti a fornire alle cancellerie un quadro degli sviluppi delle varie mobilitazioni, una volta avviate. Né poteva essere ignoto ai governanti della Triplice Alleanza che cosa si nascondesse, quanto enorme spazio territoriale e quale gigantesca quantità di risorse vi fosse alle spalle di Stati europei come il Regno Unito o la Francia o la Russia. In particolare, non prevedere poi come lo scoppio di un conflitto con l’Inghilterra e la Francia, ma anche con il Belgio e il Portogallo, avrebbe comportato fatalmente la perdita delle non esigue colonie africane — il Togo, il Camerun, l’attuale Namibia, il Tanganica — e asiatiche del Reich.
La guerra, quanto meno per il principio di precauzione — ma questa nozione è di elaborazione alquanto più tarda — o per semplice prudenza, andava evitata. Vi era poi una dottrina, quella cattolica, già allora emarginata, relativa alla "guerra giusta", che indicava chiaramente, fra i motivi per non fare una guerra, il probabile maggior danno derivante dal conflitto rispetto a quello di mantenersi in una situazione valutata ingiusta. Per fare un esempio, davvero arrivare a Trento e a Trieste (e Bolzano) valevano davvero la pena di associarsi a un massacro che nel solo primo anno — l’ho sentito affermare in almeno tre documentari sulla guerra, ma non sono riuscito a reperire la fonte —, aveva già stroncato quasi un milione di vite? Non era più conforme al bene comune che migliaia di giovani italiani, invece che immolarsi per "liberare" gl’italiani sudditi asburgici, continuassero a vivere, a formare o ad allargare famiglie, a incrementare con il lavoro e ingegno il benessere del Paese? E poi era davvero così intollerabile vivere sotto il regime austriaco? Perché rivestiva una priorità assoluta, al punto da venire prima delle vite di tanti giovani italiani, il disegno — utopistico, come tutti i disegni analoghi — di portare tutti gl’italiani entro i medesimi confini?
E un quesito analogo si può porre riguardo all’Alsazia, al dominio dei mari inglese, agli slavi del Sud, a tutte le questioni politiche allora sul tappeto. Giungendo poi al limite di chiedersi quale ingiustizia pativano gli americani, tale da indurli a trasferire in Europa quasi due milioni di soldati per ammazzare nemici reconditi — molti dei quali con parenti dall’altra parte dell’oceano — e per riportarne a casa almeno cinquantamila in una bara?
Non mi pongo assolutamente in una prospettiva pacifista, bensì cerco di essere realista: una guerra, anche un conflitto moderno, anche "asimmetrico", anche non meramente difensivo — condizione che allo stato puro si dà ben di rado —, è lecito solo quando questa "antica festa crudele" — come s’intitolava un vecchio saggio sulla guerra — sia l’unico efficace mezzo per ripristinare la giustizia violata e il danno di farla non superi l’utile atteso. E non mi pare che il dominio della Corona asburgica — che aveva "donato" all’Italia Lombardia, Veneto e Friuli per le mani di Napoleone III — sul Welschtirol (il Trentino), sul Tirolo del Sud e sulla Venezia Giulia non fosse da secoli un diritto autentico. Forse contraddiceva l’autodeterminazione dei popoli — ma non era l’unica situazione in cui questo principio veniva contraddetto, dentro e fuori dell’Austria, come insegnava proprio in quegli anni la crisi irlandese —; forse far valere i diritti dinastici era poco democratico e un po’ antiquato — ma anche che qui che dire delle altre dinastie? —: ma era un diritto reale e riconosciuto per secoli, anche se senz’altro del tutto "negoziabile", come peraltro fu — durante il "mercato delle vacche" che precede il "maggio radioso" —, anche se invano.
Proprio qui, in questa miopia generale, in questo avviarsi di tutti a testa bassa su una strada senza ritorno, pensando e dichiarando, come molti — forse non tutti, ma molti — fecero allora, che si sarebbe trattato di un conflitto localizzato di breve durata, credo si possa avere la prova di come nel tumulto delle decisioni umane si inseriscano talora elementi impalpabili e imponderabili, non sempre casuali, che si rivelano a posteriori determinanti.
Forse ad accecare i majores europei — molti dei quali scompariranno uti singuli e come ceto nel conflitto — fu l’orgoglio nazionale straripante; forse il cinismo, frutto di secoli di cattivo machiavellismo e di una profonda amoralizzazione dell’agire politico; forse la coltivazione di hidden agendas ideologiche accanto e dietro alle politiche ufficiali. I rapidi voltafaccia di Stati come l’Italia, che infrange dopo oltre trent’anni il patto della Triplice Alleanza, o come il regno di Romania o la Grecia; i mutamenti di linea politica di più di un partito o gruppo lasciano intravedere le enormi pressioni che le lobby — i poteri forti" di allora: le logge più oltranziste, i circoli militari-industriali, le società segrete razziste e ultranazionalistiche, la stampa — esercitano fra l’estate del 1914 i primi mesi del 1915 perché suoni l’ora di Marte. Oppure, forse, "quem Iuppiter vult perdere, dementat prius"…
Con molta probabilità dopo Sarajevo nessuno desiderava un conflitto globale, ma nessuno seppe arrestarne la meccanica dello scoppio.
6. "Errare humanum est, perseverare diabolicum"
Gli stessi quesiti si possono porre anche in relazione alla prosecuzione e alla durata dello scontro.
Il bilancio delle vittime del conflitto sarà assimilabile a un crescendo rossiniano: dal milione a metà del 1915 a quanti milioni nel 1917? Perché le potenze a un certo punto non hanno fermato la carneficina? Come mai tutte non hanno tenuto conto che, se i mezzi di uccisione di massa nel 1914-1915 hanno già prodotto perdite spaventose, il loro incoraggiato sviluppo tecnico — nuovi esplosivi, gas, carri armati, aerei, sotomarini — e il loro incremento quantitativo avrebbero prodotto esiti ancor più devastanti?
Altra considerazione: nel 1916 gli austro-tedeschi hanno raggiunto gran parte dei loro obiettivi bellici. Hanno umiliato la Serbia; si sono ingranditi a est ai danni della Russia; hanno ottenuto una forte intimidazione dell’asse franco-inglese con l’occupazione del Belgio e di parte della Francia; sono riusciti a contenere facilmente, prendendosi per di più il gusto di una spedizione punitiva — la Strafexpedition —, la spinta italiana e gli assalti sugli altri fronti meridionali. Perché, ci si può chiedere, non hanno ritenuto a quel punto di avviare dei negoziati di pace? Forse sarà stato troppo tardi, ma è un fatto che neppure vi si sono provati.
Persino nel 1917, quando la strage raggiunge livelli inimmaginabili di crudeltà e di infruttuosità, nonostante che papa Benedetto XV, appellandosi ai capi delle nazioni, chieda accoratamente una tregua, nulla riesce a indurre i re, i presidenti e i generali — tranne, anche se senza esito, il nuovo imperatore austro-ungarico Carlo — a porvi fine… Anzi, sarà quello l’anno in cui un milione di americani sarà dispiegato sui fronti occidentali, quasi ad mantenere stabile la quantità di "materia prima" della carneficina, una volta venuta meno la componente russa. Eppure proprio l’ingresso in guerra degli Stati Uniti è eloquente per segnalare che la disparità dei due fronti è ormai diventata insanabile e che per gl’imperi centrali, prostrati del blocco navale, la situazione volge al peggio.
Forse il persistere ostinato nell’"inutile strage" deriva dalla distanza che, nonostante secoli di ugualitarismo, si è creata fra la cultura identitaria delle classi dirigenti post-rivoluzionarie e i rispettivi popoli. La storiografia classista sottolinea — non a torto — che la visione del soldato da parte degli Stati Maggiori rifletteva l’arroganza del borghese rispetto all’operaio e al contadino del tempo di pace.
In relazione al tema della mobilitazione delle masse, colpisce per diametrum vedere quanto forte sia stato l’ascendente che i "signori della guerra" hanno esercitato, non solo attraverso le bugie della propaganda e la legge marziale, sui milioni di combattenti. In effetti i fenomeni di ribellione o di renitenza, anche in presenza di ingiustizie da parte degli alti comandi talmente patenti da sfiorare il crimine — si vedano, come esempio, le immani stragi delle undici battaglie dell’Isonzo, dove, per inciso, non si tratta di difendere la madrepatria, come a Verdun o sulla Somme, ma di conquistare con la forza territori di un altro Stato, per di più di un ex alleato —, nonostante il rilievo che ha dato loro la storiografia di sinistra, sono stati, tutto sommato, ridotti. Milioni di contadini, di operai, d’impiegati, di borghesi, d’intellettuali di ogni nazione hanno voluto o accettato di morire in maniera cieca e spesso inumana per obiettivi dei quali, non solo non avevano la nozione precisa, ma neppure erano informati. E questo fa riflettere su diverse realtà, non ultima quella dello sviluppo dei mezzi coercitivi e d’influenza che gli Stati moderni e le loro ideologie o mitologie sono riusciti a conseguire all’alba del secolo scorso.
A spiegare la tragica cecità e l’ostinazione dei comandi pare realmente difficile individuare elementi concreti e misurabili. Eppure vi è stata. A sciogliere l’enigma è così fuori luogo allora postulare l’azione di un quid di misterioso, assai simile al mysterium iniquitatis scritturale, che insinua una Schadenfreude, un generale desiderio di rovina e di morte, nelle cancellerie e nelle corti d’Europa?
Lo storico, in ossequio allo statuto epistemologico delle discipline storiche, deve prescindere dalla considerazione di questi elementi. Ma, quando si dà una sproporzione così enorme fra i moventi invocati — la vendetta dell’attentato di Sarajevo — e i fatti — quasi dieci milioni di morti ammazzati — francamente è difficile limitarsi alle cause di ordine meramente naturale. Di certo, nel caso della Grande Guerra, lo storico deve assegnare un peso straordinario, postulandone un influsso quasi religioso nella storia, alle ideologie moderne. Ma questa prospettiva, anche esasperata, non riesce a rispondere adeguatamente.
Da storico credente sono tuttavia persuaso, che, se è giusto che lo storico deve arrestarsi qui, la fede ha molto da dire nella spiegazione dei fatti della storia e aiuta anche a capire i perché del primo conflitto mondiale.
Storico o no, il credente, se vuole capire il nostro tempo, non può prescindere, per esempio, da quanto è rivelato da quella finestra sulla dimensione a-temporale della storia del Novecento spalancatasi proprio nel 1917 a Fatima, in Portogallo, una delle nazioni in conflitto. Le rivelazioni che la Chiesa cattolica attribuisce alla Madre di Gesù apparsa a tre piccoli pastori sono di fatto un outlook agghiacciante sui mali del secolo e sui loro tragici sviluppi e imminenti sviluppi, mentre contengono elementi diagnostici che ricalcano, rafforzandoli con la luce soprannaturale, quelle interpretazioni causali che pongono l’accento sugli elementi immateriali. Nelle parole attribuite a Maria, si legge come l’ateismo rivoluzionario ha provocato l’apostasia delle nazioni spingendole fino alla guerra, quella in corso e quella che poco dopo le farà seguito, allo stesso tempo frutto e castigo in temporalibus della prima; come negli anni successivi al 1917 si diffonderà nel mondo, quale castigo dell’apostasia dei popoli, l’"inferno" comunista; e come da esso si potrà uscire solo attraverso una demestriana "rettificazione dello stato in cui si è caduti", ossia attraverso la conversione dei popoli alla legge di Dio e al Vangelo. Si tratta di una fonte di certo "confessionale" e tutt’altro che a-valutativa, ma tremendamente aderente ai fatti e dotata di enorme autorevolezza, non tanto perché di origine divina, ma perché i fatti pronosticati — la fine della prima guerra, la seconda, il comunismo, la parziale conversione della Russia e il crollo dell’impero sovietico — si sono clamorosamente avverati.
Fatima così conferma la nozione di rivoluzione come apostasia sociale e come punizione essa stessa, nonché di guerra come sanzione temporale per la rivoluzione.
7. Conclusioni
In conclusione, se l’immagine della Grande Guerra si fa ogni giorno più ad "alta definizione", la sua lettura è ancora lontana da conclusioni stabili: gli studi hanno chiarito molto, ma le zone d’ombra sono ancora parecchie e l’ombra in molti luoghi regna tuttora fitta. O, più correttamente, le molte cause messe a fuoco degli storici non rispondono alla domanda: qual è la causa? Non basta infatti giustapporre causa a causa: si finisce così per perdere il filo. E, come ho detto sopra, una lettura puramente naturalistica o materialistica non riesce a farci giungere, o, almeno, ad approssimarci, all’essenza.
Il centenario che si è aperto quest’anno sarà senz’altro un’occasione propizia per capire di più e per avanzare nell’interpretazione. Rimane il dubbio che la "laicità" e l’avalutatività degli accostamenti professionali —tralascio quelli "interessati" per ragioni extra scientifiche — riusciranno davvero a capire fino in fondo questa drammatica pagina della storia umana recente.
Quello che pare, grazie al Cielo, definitivamente alle spalle, anche in ambito scientifico, è — lo dicevo all’inizio —, la lettura convenzionale, quella permeata di cattiva retorica patriottarda, da noi che ha avuto dominio assoluto negli anni del fascismo e ha intriso anche le origini e la "carta d’identità" dell’Italia repubblicana.
* * *
Riguardo al nostro Paese, è un fatto che la Grande Guerra ci ha consentito di completare, sebbene con una certa approssimazione, l’unità nazionale. Un obiettivo che, alzando il prezzo, avremmo con buona probabilità conseguito anche non facendo la guerra all’Austria e che invece ha presentato un conto di vite umane decisamente folle, specialmente se si considerano, oltre ai caduti e ai feriti, gli ammalati, gl’impazziti, gl’intossicati, i morti di stenti e di malattia, le vittime civili, le devastazioni degli abitati e le deportazioni. Senza dimenticare i costi vivi della mobilitazione di milioni e milioni di uomini e di donne, della produzione di complessi ordigni bellici, della cura dei feriti: costi valutabili in milioni di lire dell’epoca. Non voglio cadere nella retorica del "meno spade, più aratri", ma è un dato incontrovertibile che la guerra sia costata all’Italia una fortuna, mal compensata dai vantaggi derivanti dalla vittoria.
Certo, partecipando alla guerra l’Italia si è modernizzata — sia in senso tecnico, sia in senso culturale — e si è ricavato uno spazio maggiore nell’agone internazionale, ma ha rinfocolato altresì in maniera drammatica il nazionalismo, che nel ventennio successivo lancerà il Paese in avventure imperialistiche insostenibili e, alla fine — con le note ambiguità degli esordi e della drammatica conclusione —, le farà combattere un secondo scontro mondiale, da cui il Paese uscirà sconfitto e a pezzi sotto più di un punto di vista (17).
Un’ultimissima — ma solo in ordine cronologico — riflessione dedico all’impatto del conflitto sullo stato di salute etico e morale del nostro Paese, riflessione che si può estendere lecitamente anche agli altri Paesi in conflitto.
Se la vita di trincea crea solidarietà fra i combattenti e opera un amalgama determinante fra le varie "nazionalità" e culture presenti in un Paese unificato tutto sommato da poco, è anche vero che la brutalità delle condizioni di vita e la frequentazione quotidiana della morte — e di quel genere di morte creato dagli ordigni moderni — ne modificano fortemente l’atteggiamento morale. Il cinismo e l’amoralismo con cui i soldati vengono mandati a migliaia verso morte sicura, la vita bestiale imposta loro nei camminamenti e nelle buche, il loro abbandono alla fame una volta prigionieri, non può non essere assimilato da chi ha combattuto e divenirne una categoria non secondaria della visione della vita. Quelli che torneranno — ma anche le migliaia di famiglie colpite negli affetti più cari e, perché no?, nei propri interessi — saranno animati da un sentimento di rivalsa verso le alte sfere della società e non a caso i movimenti antagonisti come quello socialista conosceranno un forte incremento di consensi dopo il 1918. Più in generale l’assenza di un fondo sacrale, se non quello spurio e profano della "religione della Patria" — che sostituisce la Stella a cinque punte della massoneria, per il momento non ancora rossa, alla Croce —, alla richiesta di spendere la propria vita per l’Italia alimenterà uno scetticismo di fondo e diffonderà nelle masse uno spirito "laico", che il nazionalismo e il socialcomunismo sapranno sfruttare appieno. L’Italia che nasce dalla svolta bellica sarà così un’Italia ancora profondamente cattolica e solidale, ma non più in maniera omogenea: il processo di laicizzazione delle élite attuatosi fra Sette- e Ottocento dilagherà nelle masse italiane, sì che ci saranno ancora masse "bianche", ma la consistenza delle masse "rosse" e degli agnostici s’ingigantirà.
* * *
Tornando allo schema introdotto più sopra, la Grande Guerra rappresenta per l’Italia e per gli altri Paesi in conflitto un forte passo avanti nel percorso storico che caratterizza l’Occidente e che muove dalla frattura della cristianità nel primo Cinquecento, marciando a tappe forzate verso la dittatura del proletariato. Provvidenzialmente quest’ultimo esito non è toccato in sorte all’Italia, ma è stato il destino di molti altri e nobili popoli. I meccanismi, le dinamiche accelerate o messe in atto ex novo dal conflitto del 1914-1918 hanno alimentato, conservato, enfatizzato tutte quelle linee di forza scaturite dalla svolta del 1789 e in movimento verso l’Ottobre Rosso pietrogradese. Eliminando i brandelli di "antico regime" superstiti, abbattendo molti ostacoli al procedere della secolarizzazione e dell’ateismo, mobilitando e "nazionalizzando" masse enormi di uomini e interi settori sociali, ampliando gli apparati e i poteri degli Stati, la Grande Guerra prepara l’Europa del "secolo breve", ne anticipa e catalizza le convulsioni, e il suo retaggio sebbene alla lontana influirà ancora nella costruzione dell’Europa contemporanea.