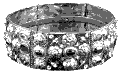Alessandro Massobrio
Da Repubblica «Superba»
a provincia piemontese:
Genova nel Risorgimento
Sul fatto che i genovesi da sempre abbiano inghiottito a stento il boccone amaro della contiguità con il Piemonte, la prova migliore è forse costituita da una vecchia tela di Domenico Piola (1627-1703), che ho scoperto in casa di un amico, letterato e collezionista. Che s’accontenta di abitare — bontà sua! — in una villa patrizia, sepolta nel verde di viale Causa, sulla cui soglia presta servizio permanente effettivo una sorta di cerbero, munito probabilmente di tre teste e di altrettante chiostre di acuminatissime zanne.
Dico «probabilmente», per la semplice ragione che il terribile mastino pare non sia mai stato scorto da occhio umano. Ma i ringhi e i latrati, che emette da dietro una porta costantemente sbarrata, hanno avuto il potere di sviluppare in tutti i visitatori una fantasia sconfinata. Tale dunque da sopperire alle prove dei sensi.
Sia come sia, in una note buia e tempestosa, una volta superata la guardia di cerbero e penetrato all’interno del maniero, eccomi finire davanti ad una antica tela seicentesca, buia e affumicata il giusto, ma non tanto da impedirmi di scorgere in essa una scena quanto mai curiosa. Una scena biblica, si sarebbe detto, in cui un omaccione nerboruto e — a quanto pareva — con pessime intenzioni, veniva a svillaneggiare una ragazzetto svelto come la fionda, che stringeva nella mano destra. Quanto alla sinistra, il nostro eroe inalberava il gonfalone di Genova. Ovvero la croce rossa in campo bianco.
«Vedi — mi spiega l’amico — il bambino è Davide e cioè la Repubblica aristocratica, che si prepara a suonarle di santa ragione a quel babbeo, grosso e stolido, che sembrerebbe essere Golia, mentre in realtà è il Piemonte sabaudo». Vicino infinitamente scomodo ed arrogante, che per fare un sol boccone di quella striscia di montagne a picco sul mare, nonché di quel porto che, alla fine del secolo XVII, rimaneva ancora il primo del Mediterraneo, non si peritava di allearsi con lo straniero di turno — in genere, si trattava dei francesi — per calare giù a valle. Con la furia di Attila, prima dell’incontro con papa Leone.
Per sua sfortuna, però, i genovesi dei bricchi, se in tempo di pace non esitavano ad uscirsene fuori in reiterati mugugni contro la rapacità fiscale della Repubblica, in tempo di guerra quegli stessi mugugni li riponevano nella cassapanca e si trasformavano in patrioti tenaci e coraggiosi.
La terra veniva difesa palmo a palmo e non era raro il caso — come accadde in quel di Busalla, sulle colline, nel 1625 — che la difesa si trasformasse in attacco e gli invasori subissero una cocente sconfitta, subito solennizzata dal santuario, il bel santuario della Vittoria, eretto di là a poco, in onore della patrona e usbergo della città. Intendo quella Vergine Maria, a cui, nel 1637, sarebbe spettato anche il titolo di Regina di Genova.
Insomma, quando i potentati, come si diceva una volta, riuniti a Vienna, dopo l’avventura napoleonica, decisero di sistemare sullo scacchiere d’Europa la regina ligure all’ombra del re piemontese, arroccato, oltretutto, in una difesa ad oltranza del restaurato ancien régime, l’entusiasmo non salì certo alle stelle. Anzi, di lì a poco, superato lo sgomento iniziale, la macchina del complotto incominciò, sferragliando, a mettersi in moto.
Bisogna sapere, infatti, che per tutto il Settecento, sotto l’occhio indulgente della vecchia Repubblica, Genova non aveva lesinato ospitalità a tutte quelle forze — intendo giacobini, framassoni e giansenisti — che sotterraneamente provvedevano a minare le fondamenta dell’Europa cristiana. Il governo napoleonico era servito per tutti costoro da brodo di coltura, sicché, quando Vittorio Emanuele I, colui che sprezzantemente i genovesi definivano «sovrano delle marmotte», decise di annoverare la Liguria tra le province del suo regno, la ripugnanza antica si sposò con il malcontento nuovo. Dando origine ad una mistura esplosiva, in cui l’ideologia veniva a sposarsi con la vocazione indipendentistica.
È una caratteristica costante, infatti, di tutta la storia della Liguria nell’età del Risorgimento questa compenetrazione tra spinte eversive carbonare e mazziniane — e dunque maturate nei salotti della buona borghesia cittadina — e il rimpianto dell’antica libertà — presente, quest’ultimo, anche a livello popolare. Anche perché il popolo di Liguria avvertiva con il fiuto delle persone semplici ma devote — quel fiuto che i teologi chiamano latinamente sensus fidei —, che i nuovi padroni, per quanto sul momento si presentassero come parrucconi e baciapile, avrebbero, primo o poi, messo mano al suo patrimonio religioso. Un patrimonio che, oltretutto, non era propriamente suo, dal momento che, trasmesso da coloro che erano stati, doveva essere consegnato inalterato a coloro che sarebbero venuti.
Fu così che, con la peggiore disposizione d’animo possibile, i genovesi videro le truppe del re di Sardegna prendere possesso delle loro città e delle loro terre. E dal momento che simili disposizioni d’animo, come già si è detto, sono il miglior fertilizzante per la gramigna del complotto — che oltretutto, in quanto gramigna, non ha bisogno di fertilizzante alcuno — ecco che i vicoli e le piazze della vecchia Zena cominciarono a pullulare di esuli o, come si diceva allora, di «patriotti», pallidi in volto e sempre languidamente tormentati da una malinconia tutta romantica. I quali poi finivano per nascondere pallore e malinconia sotto il cappuccio di una di quelle sette segrete, madre feconda delle quali era senza dubbio la massoneria.
Basti pensare, per farsi un’idea solo approssimativa del gran fervore cospirativo, che regnava tra i caruggi dell’antica Repubblica marinara, che, tra il 1824 ed il 1830, proprio a Genova il «gran maestro» Pietro da Passano avrebbe fissato il centro dell’intera galassia massonica italiana. Un centro in cui si elaboravano strategie, si pianificavano attentati, si cooptavano membri. Sempre nel nome di quella fratellanza universale, da realizzarsi in odio a trono ed altare. Le uniche istituzioni capaci — non sappiamo fino a qual punto, soprattutto per quanto riguarda il trono — di svolgere la scritturistica funzione del kathecon. Ovvero di diga nei confronti della montante marea rivoluzionaria.
I dubbi, che abbiamo avanzato a proposito della monarchia, riguardano non soltanto quella sabauda, ma l’intero processo di restaurazione, nato dal Congresso di Vienna. Una restaurazione, che era un ulteriore passo verso la rivoluzione o, comunque, una sosta esitante, un incerto oscillare tra passato e futuro, proprio in un tempo — quello del primo Ottocento — in cui la storia cominciava a subire quelle improvvise accelerazioni, che saranno poi tipiche della modernità. E nell’ambito delle quali, fermarsi o esitare significava essere reinghiottito nel baratro, da cui si tentava di uscire.
Se la restaurazione in Europa si configura, dunque, come una ulteriore concessione a quello spirito anti-cristiano ed anti-popolare, che aveva, via via, prodotto l’assolutismo del Seicento, il dispotismo illuminato del Settecento, il giacobinismo di Maximilien de Robespierre e il cesarismo di Napoleone — tutti figli del medesimo padre —, la restaurazione a Genova rivela un volto ancora più meschino e provinciale.
È la restaurazione dei «codini» e dei «parrucconi», che proclamano di voler riportare il mondo al tempo dei minuetti e dei cicisbei, senza rendersi conto del trascorrere degli anni e dei germi che l’età appena trascorsa ha inoculato nell’organismo dei popoli. E lo dimostrano le principali preoccupazioni di Vittorio Emanuele I, che si limita ad elargire graziosamente qualche favore alle classi dominanti — con Gian Carlo Brignole e Luigi Carbonara, nominati rispettivamente ministro delle Finanze e Presidente del Senato —, mentre altrettanto graziosamente le classi subalterne vengono tenute sotto schiaffo, con provvedimenti che si ispirano al più ottuso dei regimi polizieschi. Come quello, per esempio, di far redigere dallo sbirro di turno elenchi segreti, nei quali gli abitanti della Liguria venivano ripartiti in «Buoni a Genova» e «Cattivi a Genova», nonché, ovviamente, «Buoni e cattivi nelle Riviere».
Insomma, una politica, che potremmo definire più scolastica che paternalistica. Intendendo con «scolastica» la consuetudine degli insegnanti di una volta a spedire il capoclasse alla lavagna, dove, con tanto di gesso e in assenza del maestro, avrebbe dovuto scrivere — nero su bianco — i nomi degli alunni bene educati — i «buoni», per usare il linguaggio della polizia sabauda — ben separati dai «cattivi».
Ma, ahimè, dal momento che il maestro a Genova era sempre assente, in quanto impegnato ad occupare il trono di Torino ed i «cattivi» non aspettavano certo di subire il «penso» per la loro cattiveria, ecco che già a partire dal 1821 l’intera città è investita dalle prime avvisaglie di bufera. Se la costituzione, accordata dal reggente Carlo Alberto, viene accolta con violente manifestazione di esultanza popolare, altrettanto violenta è la reazione, sempre popolare, anche se manovrata da minoranze eversive, nel momento in cui quella stessa costituzione viene abrogata.
Che fare? Innanzi ad una rivolta che minaccia di trasformarsi in Rivoluzione — e con la erre maiuscola, come la scriveva Joseph de Maistre, che di simili cose se ne intendeva — l’ammiraglio Giorgio de Geneys, governatore della città, non trova di meglio da far che arrendersi agli insorti.
È un primo esperimento — chiamiamolo così — di auto-gestione, che naufraga ben presto sotto la minaccia delle baionette austriache, ma che, comunque, costituisce un seme, destinato a dare abbondanti frutti. Il seminatore, incaricato di raccoglierli, si chiama Giuseppe Mazzini, colui che — secondo il più famigerato sonetto carducciano — «giammai non rise». E non perché non avesse niente da ridere, ma per il semplice fatto che la sua educazione considerava la risata, l’umorismo, la battuta salace e magari un po’pesante come un’autentica colpa, perpetrata in dispregio a Cristo e alla sua morte in
Merito — o demerito, a seconda dei punti di vista — di una religiosità dal forte sapore giansenistico, che la madre di questo padre del nostro Risorgimento, la ben nota Maria Drago, aveva provveduto ad ammannire al figlio insieme con il latte del proprio seno. Una religiosità gelida come il sermone d’un pastore calvinista, fatta di tanti doveri e pochissimi diritti, di cristiani da redimere con ma anche contro la loro volontà e di esistenze da vivere soltanto come missione. Così come questo termine può essere inteso, per sgombrare il campo da ogni equivoco, da un’esponente dell’Esercito della Salvezza.
Coloro che, in piazza Luigi Corvetto, hanno ammirato — si fa per dire — il busto della madre, a pochi metri dalla statua del figlio, potranno farsi un’idea dell’una e dell’altro. Un’idea che comunque non può essere completa se si esclude dal panorama quell’abate Eustachio Degola (1761-1826), anch’egli genovese puro sangue, che è da considerarsi il miglior caprone, uscito dal «piccolo gregge» dell’eretico Scipione de’ Ricci. Il vescovo, che, con il sinodo a Pistoia del 1786, aveva tentato di portare a compimento un vero e proprio scisma in miniatura, troncato sul nascere, nel 1794, dalla bolla pontificia Auctorem Fidei.
Ebbene, Degola è da considerarsi l’autentica «eminenza grigia», che si muove sullo sfondo della cultura italiana del tempo. La sua influenza è avvertibile non soltanto nella formazione di Mazzini, tramite Maria Drago, ma anche — come ben sappiamo dalle storie della letteratura — in quella di Alessandro Manzoni, tramite la madre, Enrichetta Blondel. E neppure il liberista e manchesteriano Camillo Benso conte di Cavour sfugge, più o meno direttamente alla sua longa manus.
Insomma, in questo primo scorcio di secolo, a Genova si formando l’intero arco costituzionale del nostro Risorgimento, dalla sinistra mazziniana alla destra cavouriana, passando attraverso il buon Don Lisander, che un po’ giansenista e vagamente rivoluzionario lo fu sempre, sino a quando la vecchiaia, come suole accadere, gli fece mettere la testa a partito.
Figuriamoci, dunque, se qualche provvedimento repressivo ed un po’ bigotto, del tipo di quelli che potevano essere concepiti sotto la parrucca di Carlo Felice, erano in grado di mettere «in sonno» una simile organizzazione a delinquere. O meglio. Il sonno magari giunse, ma fu uno di quei sonni pesanti ed agitati, nel corso dei quali certe malattie hanno modo di impossessarsi di tutto un organismo. Sino a quando, al risveglio, il contagiato s’accorge, come accadde a Don Rodrigo, cui il primo bubbone è spuntato sotto l’ascella.
Il bubbone, di cui stiamo parlando per metafora, potrebbe essere rappresentato nella realtà storica del tempo — absit, naturalmente, iniuria verbis — dalla Giovane Italia, l’organizzazione creata da Mazzini intorno al 1831, la quale, col suo proclamarsi «non setta o partito, ma credenza ed apostolato», rivendicava un ruolo di assoluta originalità tra tutte le forze eversive dell’ordine costituito, presenti nella Penisola.
In effetti, accantonati tutti i cerimoniali di origine massonica, il nuovo gruppo politico si votava invece ad un’opera di appassionato proselitismo, con lo scopo di educare le masse e di preparare quell’insurrezione nazionale, cui sarebbe seguita una «guerra per bande», da protrarsi sino alla completa liberazione d’Italia.
Insomma, terrorismo, ma terrorismo praticato secondo metodi scientifici e, naturalmente, patriottici. Il carattere della scientificità conferisce alla dottrina insurrezionalistica di Mazzini lo stesso aplomb di rigoroso distacco che avrebbe conferito a quella marxiana. Non dimentichiamoci, infatti, che siamo negli anni in cui il positivismo di Auguste Comte faceva proseliti in tutta Europa. E dunque appiccicare l’etichetta di «scientifico» alla vecchia eliminazione fisica degli avversari politici o alla lettura in chiave materialistica della dialettica hegeliana non poteva non ottenere un grande successo presso quegli intellettuali, che a queste elucubrazioni avevano il tempo di prestare orecchio.
Oltretutto un esperimento scientifico, che si rispetti, non può prescindere dall’immolare qualche cavia sul proprio cammino, sicché morti e feriti rientrano in quelli che potremmo definire «incidenti di percorso». Fatti incresciosi, ma inevitabili, se considerati nella prospettiva del trionfo dell’idea.
Solo che di simili «incidenti di percorso» la Giovane Italia cominciò, ad un certo momento, ad abusare. Lo dimostrarono, proprio a Genova, i tentativi insurrezionali del 1831, che ebbero come unico esito un lungo periodo di chiusura dell’università ed il suicidio in carcere di Iacopo Ruffini, che per non rivelare i nomi degli altri congiurati, si tolse la vita nelle prigioni di Palazzo Ducale.
Solo tre anni dopo, nel 1834, la storia ebbe a ripetersi, ma questa volta con l’esordio sulla scena politica di Giuseppe Garibaldi. Un giovane nizzardo, destinato nell’immaginario collettivo del tempo ad occupare il posto che Ernesto Che Guevara occupa saldamente in quello di oggi. Garibaldi avrebbe poi proseguito il suo apprendistato rivoluzionario in quegli scenari sud-americani, che a lungo — si pensi al Nostromo di Joseph Conrad — avrebbero conservato memoria delle sue imprese.
Ma la rivoluzione, particolarissima merce di esportazione, è spesso destinata a ritornare al mittente. Sicché Genova avrebbe presto rivisto, dopo la parentesi rioplatense e massonica, l’Eroe dei Due Mondi a spasso per gli scogli delle sue riviere. Nel frattempo, comunque, la città godeva di un insperata boccata di ossigeno. Ad inalarglielo — strano ma vero — era stato il nuovo re di Sardegna, quel Carlo Alberto, che sembrava voler mostrare ai genovesi quanto la loro prevenzione nei confronti del Piemonte fosse infondata.
In realtà, al suo esordio come testa coronata, il giovane sovrano non soltanto aveva lanciato segnali accattivanti nei confronti dei suoi sudditi liguri — e genovesi, in particolare — come nel caso dell’epidemia di colera del 1835 —, ma, pur senza esporsi in prima persona, tollerava che i fermenti mazziniani si concretizzassero in iniziative più efficaci.
La città divenne così, nei primi anni Quaranta del secolo, il laboratorio di quel tentativo di cooperazione tra moderati di ispirazione monarchica e rivoluzionari repubblicani che la prima Guerra d’Indipendenza si sarebbe incaricata ben presto di vanificare. Ma sino ad allora molte furono le tappe di un viaggio compiuto insieme: dal Congresso Scientifico del 1846, che avrebbe avuto il suo apice nel Comitato dell’Ordine, presieduto da Giorgio Doria, Nino Bixio e Goffredo Mameli, sino al pellegrinaggio dell’anno seguente al santuario di Oregina, dettato da una aperta volontà provocatoria nei confronti di Vienna.
È il 18 marzo del 1848. All’annuncio dell’insurrezione di Milano da Genova partono i primi contingenti di moderati e democratici, che da tempo, dalle colonne de La Lega Italiana, uno dei primi giornali riformatori della Liguria, avevano propugnato una collaborazione con la monarchia, che si proponesse come scopo l’indipendenza nazionale.
Intanto, nelle elezioni del 30 aprile dello stesso anno, nasce il primo parlamento costituzionale subalpino, presieduto da Cesare Balbo, che annovera tra i suoi ministri due genovesi: il giureconsulto Vincenzo Ricci agli Interni e il marchese Lorenzo Pareto agli Esteri. Entrambi ardenti sostenitori della guerra ad oltranza contro un’Austria, che si diverte a giocare con il piccolo Stato sabaudo come il gatto con il topo.
La sconfitta di Custoza costituisce non non soltanto il brusco risveglio dal sogno di una facile vittoria, ma segna anche la definitiva spaccatura del fronte che potremmo definire «patriottico». Da questo momento, a Genova, moderati e mazziniani si collocheranno dalle due parti opposte della barricata. Anzi, per essere più precisi, a difesa gli uni degli spalti di Castelletto, gli altri tra coloro che quegli stessi spalti avrebbero inteso spianare.
Ma perché tanta animosità nei confronti di una fortificazione, che, strategicamente parlando, era forse, per il controllo della città, meno importante dei tanti forti che le fanno corona? La spiegazione, ancora una volta, deve essere ricercata più nell’orgoglio nazionale, che in ragioni di ordine logistico. Costruito nel 1815, subito dopo l’annessione della Liguria al Piemonte, il Castelletto rappresentava per i genovesi l’emblema della propria dignità di libera repubblica calpestato ed umiliato.
Al tempo delle prime caute riforme, non pochi democratici ne avevano sollecitato lo smantellamento. Ma la realizzazione del progetto era sempre stata differita, sino a che una proposta di legge, presentata alla Camera da Cesare Leopoldo Bixio, veniva approvata con 86 voti a favore e con 61 contrari. I lavori di demolizione, affidati alla Guardia Nazionale, avevano tuttavia subito un improvviso stop al momento dell’armistizio di Salasco, con il quale Carlo Alberto, interrotte le ostilità con l’Austria, ripassava con l’intero esercito il Ticino, gettando nella costernazione i patrioti italiani.
Una costernazione che, soprattutto a Genova, poteva, da un momento all’altro, tramutarsi in aperta rivolta, se la folla dei malcontenti avesse trovato quella minoranza ideologicamente organizzata cui affidare la propria esasperazione. Ancora una volta furono gli estremisti mazziniani del Circolo Italiano a fornire gli uomini giusti al momento giusto. Era il 16 agosto del 1848: i rivoltosi, opportunamente sobillati, si impadronivano del forte, danneggiandolo in maniera irreparabile.
Ma l’episodio, per quanto grave, doveva costituire soltanto una sorta di proemio a quella autentica tragedia, a cui i bersaglieri regi avrebbero dato vita, appena un anno dopo, nel cuore stesso della città. La «fatal Novara», come l’avrebbe cantata il Carducci, si era appena conclusa, così come doveva concludersi e cioè con una autentica dèbacle per le forze sabaude, che già Genova insorgeva. Questa volta, con la precisa intenzione di rigettare nelle sue valli il
Rivolta antimonarchica, sollevazione mazziniana, ultimi aneliti di un indipendentismo che a lungo aveva covato sotto la cenere? Difficile stabilire con sicurezza le cause prossime o remote di quell’aprile di sangue. Facile, invece, prevedere la reazione di Torino, la capitale di un regno, che da poco, dopo l’abdicazione di Carlo Alberto, era passato sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II. Altro padre della patria, caro alla retorica dei sussidiari della nostra infanzia.
Il «re galantuomo», che prediligeva le maniere spicce un po’ con tutti quelli — fossero stambecchi, belle contadinotte, preti e magari anche popoli —, cui frullasse l’idea di mettersi di traverso per la sua strada, decise, anche in questa occasione, di optare per la mano pesante. Avuta notizia della rivolta genovese, decise, seduta stante, di affidarne la repressione alle truppe scelte del generale Alfonso Lamarmora. Tanto più che quelle truppe — i celeberrimi bersaglieri — non soltanto erano scelte ma anche fresche, dal momento che, per motivi storicamente ancora oscuri, non erano state impiegate a Novara.
Quanto avvenne nel capoluogo ligure, in quella circostanza, è uno di quegli episodi su cui la storia e gli storici preferiscono sorvolare. Autentiche sacche d’ombra mai illuminate dal raggio della memoria dei vincitori, simili fatti vergognosi vivono comunque ancora nella coscienza collettiva, magari attraverso una sorta di trasmissione orale, di cui è giusto dar conto ai posteri. Affinché non se ne perda anche l’ultima rimembranza.
Una rimembranza di sangue, di violenza e di saccheggio. I bersaglieri, infatti, non soltanto non esitarono a bombardare la città — compreso l’ospedale di Pammatone, con le decine di feriti e malati che vi erano ricoverati —, ma, una volta penetrati nel perimetro urbano, si abbandonarono a stupri, assassini, saccheggi ed atti vandalici del tutto gratuiti. Come scrisse più tardi lo storico francese Charles De Mazade, anche Genova — con qualche decina d’anni d’anticipo — visse la tragica esperienza parigina della repressione della Comune del 1871 da parte delle truppe dei versaillesi. Anche se qualcuno, anziché ai versaillesi, preferì paragonare i bersaglieri ai mercenari croati, celebri per la loro barbarica ferocia.
Genova dunque fu «croatata» e tale rimase nei mesi seguenti. Una cadavere più che una città viva ed operosa, per usare un’immagine di Nino Bixio, che, pure, di massacri — si pensi a quello che venne perpetrato per suo ordine a Brönte, durante l’impresa dei Mille — se ne intendeva. Una città su cui regnava una calma irreale, come se nelle orecchie degli abitanti continuassero a risuonare quelle scariche di fucileria, che i soldati del re avevano creduto bene di dover indirizzare contro di loro. Anziché contro le truppe del maresciallo Johann Radetzky.
Se Vittorio Emanuele pensava comunque di avere, con quella «operazione chirurgica», estirpato, una volta per tutte, la mala pianta della rivoluzione, si illudeva di grosso. Già al principio del 1850, i mazziniani riprendevano fiato: si fondavano le prime società operaie, che, a differenza di quelle piemontesi, si prefiggevano scopi non soltanto sociali ma anche politici.
Fra tutte, ebbe modo di distinguersi quella Società del Tiro a Segno, che divenne subito uno dei principali centri di raccolta e di azione politica del movimento democratico settentrionale. Fondata da Nicolò Ardoino, Antonio Burlando, Antonio Mosto, Nino Bixio e Francesco Bartolomeo Savi, l’associazione, che si proponeva come scopo di facciata l’addestramento all’uso della carabina da parte dei giovani del quartiere della Foce — il poligono di tiro si trovava, infatti, accanto all’antico Lazzaretto, dove il Bisagno si getta in mare —, era in realtà un centro di selezione e reclutamento militare e politico della futura milizia rivoluzionaria.
Non c’è da stupirsi, pertanto, se non pochi membri della Società parteciparono con i mazziniani di Livorno ai moti del 1857 e non deve neppure destare meraviglia se, proprio in questo ambiente, si maturò, il 25 luglio dello stesso anno, l’ultima sfortunata spedizione di quello che gli storici sono soliti definire «il decennio di preparazione». Mi riferisco al tentativo di Carlo Pisacane e dei suoi trecento di far insorgere il Regno delle Due Sicilie, nel nome di una rivoluzione sociale e socialista, che certamente non poteva essere vista di buon occhio né da Karl Marx né, tanto meno, da Mazzini.
Fatto sta che fu con questo materiale umano, non sempre di prima qualità e quanto mai eterogeneo — accanto ai sognatori e ai «bravi ragazzi», vi erano i poco di buono e gli avventurieri, che nascondevano sotto atteggiamenti byroniani velleità assai meno poetiche —, fatto sta, dicevo, che fu con questi uomini che Garibaldi si apprestò a compiere quella «conquista del Sud» — per dirla con le parole di un celebre libro di Carlo Alia-nello —, a cui marina inglese e massoneria napoletana avevano già assicurato una felice conclusione.
Eppure le cose non andarono proprio così. Garibaldi, accampato con il suo stato maggiore a Villa Spinola, il «palazzo giallo» di Quarto al mare, non era precisamente del migliore degli umori. E non soltanto per una fastidiosa artrite che lo tormentava da giorni. In realtà, il generale vedeva dileguarsi quella prospettiva di festosa scampagnata, su cui i «poteri forti» internazionali gli avevano fatto contare. Intorno a sé, infatti, non aveva radunato che cinquecento uomini. Quanto poi alla rivoluzione popolare, che — come gli assicurava Francesco Crispi — avrebbe neutralizzato la reazione borbonica, neppure l’ombra.
Che fare? Vi fu un momento in cui, nonostante il febbrile andirivieni degli uomini della Società del Tiro a Segno (Montanari, Bixio, Mosto) e degli ufficiali della guarnigione piemontese, che premevano per essere reclutati nell’impresa, Garibaldi sembrò sul punto di rinunciare a tutto, fare i bagagli e tornare a Caprera. Dove avrebbe reindossato, sia pure temporaneamente, i panni del Cincinnato, dal momento che la fine di Pisacane — anche lui, per sommo di iella, partito da Genova — pare non gli andasse precisamente a fagiolo.
Ed invece... Ed invece fu la notte tra il 30 aprile ed il primo maggio a dissipare le ultime remore. A Villa Spinola, si festeggiò sino a tardi la difesa di Roma contro i francesi di undici anni prima. Quei festeggiamenti, quell’euforia furono di buon augurio. Sul far del giorno, giunsero infatti le notizie tanto attese dalla Sicilia: Marsala era caduta in mano agli insorti e i «picciotti», che si preparavano a seguirlo, erano tanti da formare un piccolo esercito.
Non restava che salpare — e al più presto — alla volta dell’isola. Fu a questo punto che una nuova protagonista si inserì nella vicenda. Una protagonista magari, sulle prime, ricalcitrante, ma che per i destini di Genova avrebbe contato più dello stesso Garibaldi. Intendiamo riferici alla compagnia di navigazione Rubattino, che avrebbe dovuto fornire le navi per l’attraversamento del Tirreno, ma che, nella circostanza, non parve disposta a concedere un bel niente. Neppure due vecchie tinozze come il Piemonte e il Lombardo, che ormai venivano unicamente utilizzate per il trasporto di merci e di emigranti. E se un agente della compagnia stessa, un certo Fauchè, non ci avesse messo, per così dire, la coda, Garibaldi e Bixio sarebbero probabilmente rimasti sullo scoglio di Quarto con i piedi a mollo e lo sguardo — rigorosamente ceruleo — rivolto laggiù, verso l’orizzonte. Dove quella Sicilia, in cui i Borboni — secondo lord Henry Palmerston — avevano impiantato un regime che era addirittura la «negazione di Dio», ancora li starebbe aspettando. E magari senza neppure troppo rimpiangerli.
L’impresa garibaldina segna per Genova il definitivo decollo di quelle dinastie borghesi, che in Germania sarebbero state immortalate dalla penna di Thomas Mann nei Buddenbrook e che trovano invece in Liguria, nella persona di Raffaele Rubattino — uomo simbolo di un’imprenditoria capace di cogliere al volo le direttive della politica di Cavour — un luminoso esempio.
In pochi anni, l’armatore, approfittando anche dell’appoggio del governo, che gli aveva anticipato quattro milioni di lire senza interessi per potenziare la propria flotta, inaugura una linea di passeggeri e merci, che, nel 1868, congiungerà Genova ad Alessandria d’Egitto. E quella di Raffaele Rubattino è soltanto una vicenda esistenziale tra tante altre, per molti versi analoghe alla sua.
Qual è l’elemento comune che collega tra loro queste saghe familiari sotto il segno di un comune destino? Senz’altro, la fede laica, anzi, meglio ancora, laicista, che unisce gli uomini della Destra storica, nelle «magnifiche sorti e progressive» da cui si sentono attesi e come investiti. Guardiamoli, nei dagherrotipi dell’epoca, questi severi signori che, da sotto le proprie tube professorali, gettano sguardi accigliati sulla posterità che avanza e che, in base all’inoppugnabile legge dell’evoluzione, non potrà che essere migliore dei propri predecessori.
In attesa dell’avvento dei figli dei propri figli costoro si preoccupano di mutare il volto alla città, affinché alla pietra sia dato di realizzare quanto essi negano alla natura umana: la capacità di sopravvivere a se stessa, dopo la morte. Via Roma, via Assarotti, corso Firenze, piazza Corvetto assumono così quel tono magniloquente, che possiedono certi mausolei familiari all’interno del recinto del cimitero di Staglieno. E questo proprio mentre gli antichi monumenti cristiani della città — porta Pila, porta Lanterna, il convento di S. Sebastiano — sono rigorosamente rimossi. Quasi ad imprimere nelle coscienze che l’unica immortalità concessa ai figli d’Adamo non supera i confini della gloria terrena.