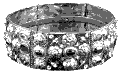I recentissimi venti di guerra hanno rilanciato prepotentemente il problema della nazionalità, ossia dell’identità dei popoli, e del legame fra questa identità e le radici religiose.
In effetti, se guardiamo alla realtà dell’Italia di questi anni, non si fa fatica a rilevare il senso dell’italianità sia andata sempre più scolorendo e il legame fra soggetti compartecipi di una medesima realtà istituzionale e politica, nonché protagonisti di una storia comune che viene a mano a mano sedimentando, sia andato allentandosi. Gl’italiani di oggi, nell’assenza di opportunità o di sfide più serie — non mi auguro, sia ben chiaro, che abbiano a riscoprire le differenze di nazionalità come probabilmente le scoprì mio padre sotto le granate britanniche in Africa Settentrionale nel 1940 —, si ricordano di essere italiani al momento delle sfide calcistiche internazionali oppure — ma sono sempre meno gl’interessati — quando qualcuno dall’alto del Colle si muove per apporre una corona d’alloro a questo o a quel monumento in occasione di qualche ricorrenza.
Non si tratta di una novità, è vero, ma credo valga la pena soffermarsi un attimo per cercare di capire almeno per sommi capi perché.
Il percorso dell’identità italiana prende le mosse dal sentimento impalpabile ma diffuso di appartenere a un’unica entità etica, che caratterizza l’Italia pre-risorgimentale. Dopo Porta Pia si passa invece a una identità sostanzialmente alternativa, secolarizzata e moderna, elaborata a tavolino su basi ideologiche, sganciata dal dato naturale e dal passato — l’identità come determinata dall’eredità — per essere proiettata verso un futuro ideale che, a seconda delle sfumature, è la democrazia, la grandeur nazionale, il socialismo. Tale visione presuppone obbligatoriamente l’alterazione della memoria storica recente e meno recente e la scuola come strumento della sua veicolazione al popolo.
La situazione in cui vive l’Italia fino all’incirca alla vigilia del primo conflitto mondiale vede la contrapposizione fra due culture, quella dell’Italia «ufficiale», progressiva» e secolarizzata, e quella dell’Italia di sempre, le cui radici affondano nella notte dei secoli. L’Italia si trova di fatto divisa, secondo una felice espressione, in un «paese legale» — la minoranza che detiene il potere politico, culturale ed economico — e in un «paese reale» — le classi medie e i ceti popolari, ossia la maggioranza degli italiani delle campagne e delle città, fra cui è ancora viva la tradizione religiosa e civile preunitaria.
Ci vorrà il colossale amalgama attuato dalla prima guerra mondiale che sposterà masse mai viste di italiani dalla loro terra di origine al fronte, la mescolanza delle identità locali nelle trincee e nel crogiolo dei combattimenti — così come la diffusione delle ideologie moderne attraverso la stampa e l’attivismo politico fra le masse contadine e operaie — per ridurre il gap fra la classe politica liberal-monarchica uscita dall’unificazione e le masse cattoliche e socialiste.
Sarà il fascismo, attraverso il mito del Piave e di Vittorio Veneto, a corroborare più intensamente l’immagine dell’Italia uscita dal Risorgimento e a dare il maggior impulso alla «nazionalizzazione delle masse» italiane. Ma sarà la guerra da esso scatenata e persa, con gli orrori dei bombardamenti e della guerra civile, e soprattutto il crollo dello Stato l’8 settembre 1943 a infliggere a questa concezione dell’Italia, sostanzialmente artificiale e in antitesi con il suo passato, il colpo più duro.
L’Italia riemerge ferita ma non morta dalle rovine della sconfitta e si risolleva a poco a poco non grazie alla monarchia, presto esiliata, né all’esercito, che per molti anni vivrà in una condizione di minorità e di sospetto, e neppure grazie alle ideologie risorgimentali — anche se tornano a sirene spiegate —, ma in virtù delle proprie radici ataviche che neppure l’8 settembre ha potuto svellere: il suo senso religioso cristiano, la creatività del ceto imprenditoriale, la laboriosità delle classi lavoratrici, l’onestà dei costumi, la qualità delle sue scuole, la saldezza dell’istituto familiare, la natalità.
Ma anche se ritorna la vecchia identità ideologica — integrata dal nuovo mito cosmetico della Resistenza —, nell’Italia repubblicana di essa paiono scordarsi più o meno tutti, chi preso dalla militanza di partito, chi dal patriottismo di campanile, chi dal tifo calcistico, chi dai primi deliri canori e dai quiz televisivi. L’Italia di Porta Pia, del Piave e dei partigiani cade sempre più nell’oblio e il suo richiamo a poco a poco si spegne: segni tangibili ne sono la scomparsa delle parate e delle divise militari, e il tricolore, finito nelle soffitte.
Solo dopo il 1968 si assisterà a un revival del mito risorgimentale, ma quasi esclusivamente limitato all’ultima parte, quella partigiana, utilizzata dai comunisti per propiziare l’avvento dell’«Italia rossa» e internazionalista.
Alla fine degli anni Settanta, la liquidazione della contestazione giovanile apre — come si dice — sempre più vaste «praterie» all’oblio e al disimpegno. La maggior parte degl’italiani dimostra di non interessarsi di politica — scordando che la politica intanto s’interessa di loro, eccome! — e neppure si pone la domanda «chi sono? che cosa vuol dire essere italiano?» o perché «ha da lavorare», o perché nel frattempo al richiamo del patriottismo nazionale è subentrato quello del patriottismo europeistico o di partito o semplicemente sportivo: l’identità italiana «convenzionale» tocca così il suo punto più basso.
Dopo la caduta del Muro nel 1989 neppure l’oggettiva provocazione costituita dalla rivalutazione delle identità locali in chiave politica o culturale fatta dai leghisti e dai neo-legittimisti riesce a rianimare questa forma identitaria, ma anzi le infligge colpi sempre più duri, cui solo qualche intellettuale — più di sinistra che di destra — o qualche funzionario dello Stato reagisce.
Oggi è venuto il momento di affrontare il problema di questa identità esaurita: uno Stato moderno non può vivere con un senso dell’identità nazionale così esangue. Il momento è tanto propizio quanto cogente. Da un lato infatti non vi è più la pressione dei blocchi ideologici contrapposti, anzi le stesse ideologie moderne sono in profonda crisi, mentre dall’altro ce lo impongono sempre più insistentemente le sfide del terzo millennio: una guerra, in tesi mondiale, in corso, in cui dobbiamo schierarci consapevoli di difendere attraverso la lotta al terrorismo islamico anche la nostra specificità nazionale; il bisogno di trasmettere alle giovani generazioni valori per cui valga la pena spendere — non necessariamente donare — la propria vita; la costruzione dell’Europa. Ma anche e forse soprattutto la necessità di rispondere adeguatamente e autenticamente a quelli fra i nuovi ospiti della nostra società, che vengono da luoghi lontani e da culture molto diverse dalla nostra, e che vogliono imparare a diventare, non solo per pochi mesi, italiani. Che cosa diremo a costoro? Che siamo italiani perché lo dobbiamo a Mazzini e a Garibaldi? perché tifiamo per la stessa nazionale di calcio? perché l’Italia è la Ferrari e i vini del Montalcino?
Oppure perché siamo figli della civiltà di Roma e di quell’unicum straordinario costituito dalla civiltà cristiana medioevale, ossia la romanità vivificata dal cristianesimo e dal genio germanico? perché siamo figli primogeniti della Chiesa cattolica che proprio in Italia ha collocato la sua sede santa? perché abbiamo due millenni di storia comune, Otto e Novecento inclusi — ma senza alcuna esclusività —, da cui è stato plasmato perfino quel paesaggio dolce che tanto gli stranieri amano?
Ma per riscoprire che cosa significa essere italiani occorre chinarsi sulla memoria storica dei popoli della penisola e rileggerla in integro, cercandone la verità, senza «tagliarne via» tempi e realtà sgradite, evitando di ripetere stanchi luoghi comuni, e senza pregiudizi ideologici. Ciascuno dovrà forse rinunciare a qualche elemento della «sua» lettura della storia italiana cui è più affezionato, dovrà forse abdicare un po’ a se stesso, per cercare di costruire fin dove possibile — il limite sono le capacità della scienza storica, non altro — una visione comune della nostra memoria storica. Solo così — soprattutto non contrapponendo in chiave polemica le nuove acquisizioni storiche che si verranno facendo alla visione convenzionale — si potranno ricucire le lacerazioni che storicamente hanno diviso gli italiani per affrontare con uno stile nuovo i problemi del terzo millennio cristiano.